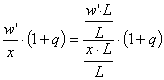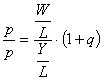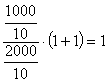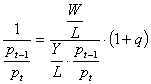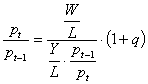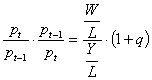|
COSTO DEL LAVORO LE RADICI DI UNA FALSIFICAZIONE Alessandra Nannei[1] Perchè non è possibile utilizzare i cosiddetti “indici ufficiali” del “costo del lavoro” per spiegare l’inflazione. Essi danno conto dell’andamento di uno solo degli elementi – il lavoro, appunto – che compongono i costi di produzione. Questo articolo era stato scritto prima del l’assassinio di Ezio Tarantelli, il cui ruolo di intellettuale operante col sindacato lo ha designato come bersaglio di un terrorismo dalle sempre più dubbie matrici. Come ha detto Sandro Antoniazzi a Radio Popolare poche ore dopo, questo terrorismo vorrebbe gli intellettuali chiusi in casa,fuori dal dibattito culturale in rapporto con l’impegno sociale. Tale dibattito è stato bloccato negli anni di piombo, col danno ben noto derivatone a/sindacato. Oggi si è imparato che la risposta non è il silenzio, ma la riflessione critica che non si lascia intimidire. Il costo del lavoro diventa il centro delle discussioni politiche, economiche e sindacali in Italia alla fine degli anni settanta. Ma il cammino attraverso cui giunge è molto lungo. Gli imprenditori hanno sempre sostenuto che i salari sono fonte di molti guai: già negli anni cinquanta gli articoli economici del maggiore quotidiano italiano avevano questa impostazione. Il passaggio al centro dell’attenzione è avvenuto, credo, attraverso economisti ed ideologi della sinistra o comunque di orienta mento progressista. È del 1972 il volume di Paolo Sylos - Labini dal significativo titolo Sindacati, inflazione, produttività, dove già l’accostamento di queste tre parole sembra preannunciare la tesi di fondo. Infatti a pag. 6 troviamo la categorica affermazione che: “...i cospicui aumenti salariali del 1969-70 hanno effettivamente contribuito all’aumento dei prezzi...”.[2] Sempre negli anni settanta i numerosi studi sulla cosiddetta “economia sommersa” ed il “lavoro nero” sostengono si tratta di risposte del sistema industriale agli elevati costi salariali all’interno delle imprese. Nel 1970 Ezio Tarantelli in Produttività del lavoro, salari e inflazione (anche qui l’accostamento è significativo) afferma a proposito dell’industria delle costruzioni, che sono evidenti le “...particolari pressioni inflazionistiche sul settore, derivanti dal minore tasso di incremento della produttività oltre che dagli incrementi dei salari”. Tali pressioni sarebbero dimostrate dal grafico che riporta gli indici del “costo del lavoro” nell’industria delle costruzioni stessa e nel resto dell’industria. In quel periodo tuttavia la grande forza della sinistra, espressa in vari tipi di comportamenti collettivi che si sono tradotti in comportamenti elettorali a metà degli anni settanta, ha impedito che queste impostazioni divenissero predominanti. È soltanto nell’inverno 1976-77 che la situazione si modifica. Nel clima della solidarietà nazionale il sindacato, in modo particolare la CGIL, accetta una impostazione secondo la quale sono necessarie misure di austerità per rilanciare l’economia italiana. Tra queste misure il contenimento del costo del lavoro, nel quale si accetta di vedere la causa principale — o almeno l’unica su cui si può intervenire — dell’inflazione. È la cosiddetta svolta dell’Eur del gennaio 1977: i leaders sindacali che avevano negli anni precedenti teorizzato il salario come variabile indipendente, accettano ora l’impostazione secondo la quale il salario è una variabile dipendente dall’andamento generale dell’economia e in particolare dalla produttività del lavoro. Contemporaneamente il governo Andreotti a partire dall’autunno 1976 adotta i primi provvedimenti di riduzione del costo del lavoro, come contributo al contenimento dell’inflazione, attraverso il pagamento degli scatti di anzianità con Buoni del Tesoro, il congelamento di quote di liquidazione e l’esclusione dal paniere di beni sui prezzi dei quali viene calcolata la contingenza (come ad esempio l’energia elettrica, le cui tariffe in quel momento stavano aumentando). Contemporaneamente le interpretazioni dei primi anni ‘70 vengono diffuse a livello di massa e diventano l’interpretazione prevalente dei mali italiani. Nelle teorie economiche tradizionali il collegamento tra salario e inflazione era solo di breve periodo, e il salario era uno dei molti costi il cui aumento poteva riflettersi, in periodi particolari di intensa attività economica, sul livello dei prezzi. Perché il salario divenisse la causa principale dell’inflazione occorreva un diverso fondamento teorico, che fu trovato nella teoria del costo pieno o del markup. Nata negli anni cinquanta, in concomitanza col progredire delle indagini sulla formazione delle decisioni all’interno dell’impresa, la regola del markup veniva a far parte di quell’insieme di regole empiriche con cui, insieme al criterio del “profitto soddisfacente”, si è cercato di dare una spiegazione più realistica al comportamento dell’impresa. La teoria del prezzo in base al costo pieno afferma che l’imprenditore stabilisce il prezzo del proprio prodotto aggiungendo al salario, al costo delle materie prime e alla quota di “costi fissi” necessari a produrre quell’unità di prodotto, una certa percentuale di profitto. Può stabilire il prezzo in questo modo perché gode di una posizione di oligopolio o di concorrenza imperfetta: in altri termini, può trasferire immediatamente sul prezzo aumenti dei costi di produzione. Accertato, attraverso inchieste alle imprese, che la percentuale di markup sul costo pieno rimane abbastanza costante nel breve periodo, e poiché i costi fissi totali sono per definizione fissi nel breve periodo e quelli unitari variano solo con la quantità prodotta, si è giunti ad esprimere il prezzo del prodotto in funzione dei costi variabili: salari, materie prime e materiali intermedi, energia, ecc. Da qui incominciano le approssimazioni. Anche i costi delle materie prime vengono espressi come percentuale dei costi salariali. In altri termini, si presuppone una costanza di rapporto tra i costi dei prodotti necessari a produrre quel bene più il profitto e i salari: costanza sicuramente inesistente nei periodi di inflazione o di oscillazione dei prezzi internazionali. A questo punto del ragionamento abbiamo già tre assunzioni: 1°) condizioni di concorrenza imperfetta e possibilità di trasferimento dell’aumento dei costi sui prezzi; 2°) costanza del margine di markup; e quindi variabilità del margine di profitto; 3°) costanza del rapporto tra costi dei diversi input più profitti e salari. Le distorsioni vere incominciano però quando si passa dalla formula teorica alla pratica. Nella formula del markup il salario — qui considerato variabile indipendente rispetto al prezzo — è la quantità di salario necessario a produrre quella unità di bene, cioè uguale al monte salari pagato dall’imprenditore, diviso per il numero di lavoratori occupati e per la quantità di beni che ciascun lavoratore produce nell’unità di tempo a cui si riferisce il monte salari. È questo il saggio salariale, cioè ad esempio il salario/uomo/ora, diviso per la quantità di beni prodotti in un’ora da un lavoratore. Già si vede che tale formula è di difficile applicazione anche nella singola impresa che produca più di un prodotto o che abbia produzioni congiunte, per l’impossibilità di sommare termini fisici diversi. Diventa pressochè impossibile applicarla su scala nazionale. Invece è proprio qui che tale formula ha avuto la maggiore diffusione. La teoria del costo pieno è stata utilizzata per spiegare non solo il livello dei prezzi, ma anche la loro variazione, e poiché qui il prezzo è tutto funzione dei salari, questi diventano la variabile che spiega l’inflazione. A livello nazionale non conosciamo il saggio salariale, non conosciamo la produttività espressa in termini fisici, non conosciamo il markup. cioè la percentuale da aggiungere al salario per ottenere il prezzo (e ovviamente, non dovremmo ex ante neanche conoscere il prezzo). Più avanti do la dimostrazione esauriente dei passaggi matematici, qui cercherò solo di descriverli. Come ho detto, non si conosce la quantità prodotta; nè, se si conoscesse, sarebbe utilizzabile, dato che in termini fisici le quantità non sono omogenee. Che senso avrebbe sommare numero di tavoli prodotti col numero di automobili, o calcolatori con frigoriferi e così via? Gli economisti sono però abituati a lavorare sui valori e non sulle quantità fisiche. Per rendere omogenee quantità diverse occorre trasformarle in unità aggregabili, e ciò si fa normalmente moltiplicandole per il loro valore o prezzo. L’abitudine è talmente inveterata ed il procedimento è considerato l’unica “scappatoia” per poter esaminare grandezze diverse, che a volte sfuggono le conseguenze che può provocare. Nelle statistiche nazionali il nostro saggio salariale viene chiamato costo del lavoro ed è calcolato dividendo il reddito da lavoro dipendente, diviso il numero di dipendenti (cioè il reddito da lavoro dipendente per di pendente), per una certa grandezza chiamata produttività, calcolata a sua volta dividendo il valore aggiunto nazionale a prezzi costanti per il numero di occupati. Questo procedimento viene seguito perché non si conoscono le retribuzioni di tutti i lavoratori, ma solo degli occupati dipendenti. Si deve quindi fare un’estrapolazione, presumendo con varie modalità che la retribuzione di un lavoratore indipendente sia uguale a quella di un lavoratore dipendente. Siamo quindi di fronte ad un altro assunto: 4°) eguaglianza tra le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e redditi dei lavoratori indipendenti. È stato notato che il costo del lavoro così calcolato non è più il costo del lavoro per unità di prodotto, ma solo la distribuzione del reddito tra i fattori della produzione (Convenevole, 1981), e quindi come tale non dovrebbe avere alcuna influenza nè sul livello, nè sugli aumenti dei prezzi. Come si arriva quindi da una formula che spiega il livello dei prezzi, ad una che ha tutt’altro significato? Mi sembra che il passaggio si debba ricercare nel diverso significato di saggio salariale, che compare nella formula originaria, di “costo del lavoro”, così come è calcolato dalle fonti ufficiali (Banca d’Italia, Supplemento al bollettino, anno XXXVI, n. 7; ISTAT, Conti economici nazionali, anni 1960 - 1983). Obiettivo di questo scritto è di dimostrare che, se è giustificato utilizzare i cosiddetti indici ufficiali del “costo del lavoro” come indicatori dell’andamento di un elemento dei costi di produzione, il lavoro appunto, non è invece giustificato utilizzarlo come variabile esplicativa dell’inflazione, nel modo così diretto come è ipotizzato dalla formula del costo pieno e come è di fatto stato utilizzato nelle contrattazioni coi sindacati negli ultimi anni. Nel ragionamento che segue, ho cercato di esplicitare tutti i passaggi matematici in un modo che ad alcuni specialisti sembrerà elementare e ridondante ma che, mi sembra, faciliterà la comprensione del lettore non specializzato. Ritorniamo alla formula del costo pieno e del markup: p = w + r dove: p = prezzo del prodotto w = saggio salariale per unità di prodotto r = costi residui e saggio di profitto per una unità di prodotto. Ponendo i costi residui ed il profitto come percentuale del saggio salariale di una unità di prodotto, si ha: p = w + w.q dove: q = r/w e quindi: p = w (l + q) (1) Come si è detto, nella pratica non si conosce w, ma solo la quantità di salario pagata nell’unità di tempo per ciascun lavoratore, che poniamo uguale a w’. Supponiamo che w’ sia il salario pagato per un’ora di lavoro a ciascun lavoratore, e che questi produca in un’ora di lavoro un certo numero x di prodotti. Allora: w = w’/x Sostituendo nella (1) si ottiene: p = (w’/x) . (l+q) (2) Che è uguale alla (1), ma dove al posto del salario per unità di prodotto si ha il salario pagato per un’ora di lavoro a ciascun lavoratore, diviso per la quantità prodotta. A livello nazionale non si conosce con esattezza il salario orario pagato effettivamente a ciascun lavoratore, ma solo il monte salario, cioè tutte le retribuzioni pagate a tutti i lavoratori dipendenti. Detti: L = numero di lavoratori dipendenti; W = monte salario Si ha che: W = w’.L Ponendo: Yc = x possiamo dividere e moltiplicare numeratore e denominatore del membro di destra della (2) per il numero di lavoratori, L:
p =
e quindi:
p =
La (4) afferma che il livello dei prezzi su scala nazionale o il prezzo dei prodotti di una singola impresa, è uguale ai salari pagati, diviso per i numero di lavoratori occupati (su scala nazionale o nell’impresa), diviso ancora per la quantità di beni prodotti da ciascun lavoratore, moltiplicato per un certo fattore (1 +q) proporzionale al salario, per tener conto degli altri costi di produzione e del profitto. Un esempio servirà a chiarire quanto detto. Supponiamo che un’impresa abbia l0 dipendenti, che paghi ogni giorno 1.000 di salari complessivi e che ogni dipendente produca ciascun giorno 20 prodotti. Supponiamo inoltre che la somma degli altri costi residui e del saggio di profitto per unità di prodotto sia uguale al salario, cioè: q = 1. Avremo allora: L = 10 dipendenti W = 1.000 x = 20 = Yc / L Yc = 200 w’ = 100 = W / L q = 1 Allora: w = w’ / 5 Sostituendo nella (1) si ottiene il prezzo di una unità di prodotto: p = 5 . (1 + 1) = 10 Ricordiamo che x od anche Yc/L è la produttività, calcolata in termini fisici, cioè come numero di pezzi prodotti da ciascun lavoratore nell’unità di tempo. La questione, che così appare molto semplice, si complica enormemente se applicata nella pratica, perché a livello nazionale non conosco nè la quantità di “pezzi” prodotti da ciascun lavoratore, nè il “fatturato” (cioè Yc . p ) prodotto ancora da ciascun lavoratore, ma neanche il salario di tutti gli occupati. Eppure a livello nazionale la formula del costo pieno viene utilizzata per indicare la relazione tra salari e prezzi, tra aumenti dei salari ed aumenti dei prezzi. È legittimo questo passaggio? Vediamo il procedimento seguito dagli organismi che forniscono i dati ufficiali del costo del lavoro. Non si conosce W, ma solo le retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti. Si conosce il numero dei lavoratori dipendenti e il numero totale degli occupati, che comprende sia i dipendenti che i lavoratori autonomi (le elaborazioni sono fatte per ciascun settore produttivo, e poi aggregate). Presupponendo che la retribuzione di un lavoratore dipendente sia uguale in media a quella di un lavoratore autonomo, attraverso interpolazione viene calcolata la retribuzione complessiva, che in prima approssimazione poniamo uguale a W. Conoscendo W ed L, si riesce così ad ottenere w’. Ma quello che è più importante è che non si conosce x nè se lo si conoscesse lo si potrebbe utilizzare. Ricordiamo infatti che x è una quantità fisica, e poichè i calcoli nazionali vengono effettuati su una serie di prodotti diversi, non sarebbe possibile calcolare una media x sommando appunto automobili a frigoriferi, o calcolatori elettronici a tonnellate di acciaio prodotto. Nelle fonti ufficiali questo impasse viene superato moltiplicando ciascun prodotto per il rispettivo prezzo ed aggregando a livello di settore. È questa un’operazione possibile? In pratica nella (4) al denominatore del secondo membro dell’eguaglianza, a: Yc/L viene sostituita la grandezza: Y/L, che è uguale a Yc/L. A parte la legittimità di sostituire un valore che si dovrebbe trovare (p dovrebbe essere un’incognita), l’operazione equivale a dividere entrambi i membri della (4) per p. Infatti perché un’eguaglianza continui a rimanere valida, se si divide (o moltiplica) un membro per una certa quantità, occorre dividere (o moltiplicare) per la stessa quantità anche l’altro membro. Allora l’operazione dà questo risultato:
Ma fornito dalle fonti ufficiali. A questo punto si vede che, semplificando:
1 =
od anche:
In altre parole, quella certa quantità che viene chiamata “costo del lavoro” per unità di prodotto, e che in realtà è un’altra cosa, non ha più alcuna relazione con il livello dei prezzi e neanche, quindi, con la sua variazione, cioè con l’inflazione. Proviamo infatti a sostituire nella (5) i valori del nostro esempio. Y dovrebbe essere il fatturato dell’impresa, cioè 200 (quantità di beni prodotti da tutti i dipendenti, Y per il prezzo che avevamo trovato, 10:
che è esattamente il valore della (6) e non il livello dei prezzi, che nel nostro esempio sarebbe 10. Ora, se questo “costo del lavoro” non può misurare i prezzi, ancor meno potrà misurare la loro variazione. La questione è ancora più complicata dal fatto che Y che si ottiene in contabilità nazionale non è uguale ad un ipotetico Y dell’impresa, ottenibile moltiplicando il prezzo ottenuto con la formula del markup per la quantità prodotta, ma è solo il valore aggiunto, cioè un insieme di redditi (salari, rendita, profitto, interesse). Non comprende quindi i costi dei beni intermedi. Allora la (7) esprime solamente la distribuzione del reddito, cioè la quota di reddito nazionale che va ai salari, secondo il membro di sinistra, cioè il costo del lavoro, e quella che va agli altri redditi secondo il membro di destra. Il denominatore del membro di sinistra della (7), cioè Y/L che normalmente viene chiamato produttività, in realtà non è che il valore aggiunto per addetto. Se questi passaggi concettuali portano alla distribuzione del reddito, come è possibile sostenere che il “costo del lavoro”, così come calcolato dagli organismi ufficiali, abbia una sua propria influenza sull’inflazione, diversa da quella di tutti gli altri elementi di costo? Già da tempo è stato notato (Samuelson, 1970) che: “in qualsiasi inflazione, anche la più pura inflazione da domanda, i saggi salariali e i profitti monetari crescono ad una velocità maggiore della produttività fìsica ” (il corsivo è mio). Criticando le indicazioni dell’allora presidente Kennedy del 1962 affinché i saggi salariali aumentassero quanto la produttività, Samuelson ricorda che in base alla teoria del costo pieno un aumento, ad esempio del 3 per cento dei salari fa aumentare esattamente della stessa quantità i profitti, per cui l’inflazione sarebbe provocata contemporaneamente dall’aumento dei salari e dei profitti. La relazione tra prezzi e salario va allora ricercata altrove, nel grado di monopolio, nei processi produttivi, nell’organizzazione della produzione e della distribuzione, e così via. Possiamo ammettere che tutti i costi siano traducibili in termini di salario, ma di un saggio salariale che non conosciamo nè possiamo conoscere: il famoso w’/x della (2). Che è un’entità diversa da quella usata nelle statistiche ufficiali. Si potrebbe giungere a calcolare w’/x con qualche approssimazione a livello d’impresa e l’approssimazione sarà tanto più arbitraria quanto più diversificata è la produzione dell’impresa stessa. A livello nazionale, questa quantità w’/x, che è veramente il costo del lavoro, potrebbe essere calcolata aggregando i costi del lavoro di tutte le imprese che operano nel territorio nazionale. Il procedimento sarebbe così complesso che è facile ipotizzare non sarà mai seguito, ma si preferirà utilizzare altri indici (Triplett, The Measurement of Labor Cost, 1983). Essendo il cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale in realtà una distribuzione di reddito, cioè la quota di salario sul prodotto interno, nei paesi in cui è più alto indicherebbe che in qualche momento del passato negli stessi paesi si sono avuti tassi di inflazione più alti di quello dei paesi in cui la quota di salari sul prodotto interno è inferiore. Infatti possiamo porre l’attuale quota di salario pari a una quota iniziale, più una certa funzione dei tassi di inflazione. E questo sembra abbastanza assurdo. Al contrario, in paesi come il Brasile dove la quota di salari è minore di paesi come la Svezia e maggiori sono gli altri redditi, sempre fatto 100 il prodotto interno, l’aumento percentuale dei salari dovrebbe riflettersi in un minor tasso di inflazione. Il solito esempio numerico basterà a constatare l’insensatezza dell’affermazione. Come noto, le statistiche ISTAT e Banca d’Italia forniscono i N.I. del “costo del lavoro”, cioè l’incremento percentuale della quota iniziale di salario sul prodotto interno. Supponiamo che nell’anno iniziale tale quota sia rispettivamente di 80 per il salario e 20 per gli altri redditi, dato 100 il prodotto interno. Se il cosiddetto “costo del lavoro” aumenta dei I0 per cento, vuoi dire che è cresciuto da 80 a 88. Si possono avere due casi: gli “altri redditi” sono diminuiti da 20 a 12 e quindi il livello dei prezzi è rimasto invariato. Non si ha inflazione. Oppure gli “altri redditi” sono aumentati di una certa quantità y, così che il livello dei prodotto interno calcolato in prezzi correnti è aumentato da 100 a 109. Ma allora il cosiddetto “costo del lavoro” è cresciuto — data la definizione — da 80/100 a 88/109, cioè sarebbe ora dell’8l / l00. In pratica sarebbe aumentato di 1/8, cioè poco più dell’1 percento. Il che è in contrasto con l’ipotesi iniziale. La questione si complica ulteriormente perché il cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale viene calcolato come rapporto tra un salario in lire correnti e un valore aggiunto in lire costanti. In altri termini ciò equivale a calcolare un costo del lavoro di un operaio, ad esempio dell’Alfa Romeo, dividendo il suo salario per il prezzo che una “Giulietta” aveva dieci anni fa. Questo mi sembra che, secondo gli elaboratori ufficiali, venga fatto per evitare il paradosso di cui al paragrafò precedente, ma in realtà si tratta di grandezze diverse non confrontabili. Il deflazionamento del valore aggiunto potrebbe essere effettuato dagli organismi ufficiali nella speranza di ottenere così il tasso di inflazione e, finalmente, l’eguaglianza tra questo e il costo del lavoro “ufficiale”. Infatti deflazionare il valore aggiunto pro-capite equivale a moltiplicare il denominatore della (6) per il rapporto tra il livello dei prezzi a cui si vuol ricondurre il valore aggiunto e il livello dei prezzi attuali. Perché l’eguaglianza sia ancora valida, occorre dividere anche l’altro membro per la stessa quantità. Si ha allora:
Il tasso di inflazione, cioè il rapporto è l’incognita da determinare. Non si conosce infatti il denominatore della (8), ma solo, tramite le indagini di base della contabilità nazionale, il primo termine del denominatore, cioè il valore aggiunto a prezzi correnti [(Y/L) . pt] Quindi dalla (8) si ottiene:
e, isolando il termine incognito :
cioè:
come nella (6). L’accorgimento di “deflazionare” il valore aggiunto che compare al denominatore del cosiddetto “costo del lavoro” equivale a predeterminare il risultato: infatti nella (9) otterrò sempre il tasso di inflazione che ho messo al denominatore del cosiddetto “costo del lavoro”. Indicando il cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale la distribuzione del reddito, a livello di settore, una sua variazione indica che vi è stato un cambiamento dei prezzi relativi (tra i beni di quel settore e gli altri prodotti dall’economia nazionale), come è stato notato (Convenevole, 1977). Quindi, secondo me, a parità di processi produttivi in due momenti diversi, esso riflette la quantità di know how incorporato nel prodotto e una sua variazione esprime non solo una variazione della composizione dei costi interni, ma attraverso questa anche il cosiddetto “ciclo del prodotto”. Con il semplice passare del tempo, poiché un prodotto ad elevato know how diventa necessariamente un prodotto “vecchio”, la di Y(di reddito) che riesce a far ottenere diminuisce e quindi diminuisce il saggio q. (altri redditi), supponendo che siano state ammortizzate tutte le spese di ricerca. Allora il cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale aumenterà anche se i salari nominali rimangono costanti. Ma può aumentare anche se il salario reale rimane invariato, cioè non muta la capacità del salario di acquistare non il bene prodotto, ma tutti gli altri beni-salario. Poiché poi una buona parte della nostra produzione è destinata all’esportazione, se il mix di prodotti che esportiamo tende a peggiorare rispetto a quello degli altri Paesi (cioè se peggiorano i termini di scambio, come di fatto è avvenuto negli ultimi dieci anni), ecco che il cosiddetto “costo del lavoro” tende, così calcolato, ad aumentare (Cf Nannei, Azimut, n. 13). E non aumenta perché, come si sostiene, si riflette sull’inflazione, ma per tutt’altra ragione. A questo punto, mi sembra del tutto errato correlare il cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale con l’inflazione. Sia perché questa relazione non esiste nel modo così semplice ipotizzato dalla teoria del costo pieno, sia perché si tratta di due variabili altamente autocorrelate. Come è stato notato (Ackley, 1970), l’inflazione può essere messa in moto dal semplice fatto che il markup non è compatibile con una situazione di equilibrio. Il processo inflazionistico da noi si è messo in moto con gli aumenti dei prezzi del petrolio nel 1973. Se, come è molto plausibile, gli imprenditori hanno calcolato il proprio tasso di profitto sul totale del capitale investito (fisso e circolante, comprendendo tra questo le anticipazioni per l’acquisto di energia, prodotti intermedi e materie prime, ed anche salari e interessi per la quota di capitale preso a prestito), può essere accaduto che questo si sia riflesso in un aumento del markup calcolato sul costo pieno, che ha dato inizio al processo inflazionistico. Ogni variazione nella distribuzione del reddito fra salari e profitti può essere allora considerata come una correzione di una precedente iniquità che si è verificata nel corso della storia (Lerner, 1970). Invece a partire dalla fine degli anni Settanta si è voluto vedere nel cosiddetto “costo del lavoro” ufficiale la causa principale dell’inflazione, il che è stato facilitato dalle anali si di alcuni economisti italiani. Si è visto in queste pagine che la relazione tra salari e inflazione non è diversa da quella tra tutti gli altri costi e redditi e l’inflazione stessa. Pertanto l’accento posto sul costo del lavoro non deriva tanto da una relazione economica esclusiva, quanto dalla capacità di un gruppo sociale di imporre, soprattutto attraverso i mass media e gli operatori culturali, una concezione dei meccanismi economici ad esso favorevole. BIBLIOGRAFIA (1) A Gardner, A Third Approach to the Analysis and Control of Inflation, in: Keiser F. Norman (a cura di ), “Readings in Macroeconomics”, Prentice-Hall, 1970. (2) Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino, Costi e profitti nel settore industriale, Anno XXXVI, n. 7, 14-2-1983. (3) Roberto Convenevole, Processo inflazionistico e redistribuzione del reddito, Einaudi, 1977. (4) Roberto Convenevole, Sono gli strumenti di analisi economica neutrali?, in: Giorgio Lunghini (a cura di), “Scelte politiche e teorie economiche in Italia 1945-78”, Einaudi, 1981. (5) Istat, Contabilità nazionale, Fonti e metodi, Annali di statistica, Serie IX, Voi. 4, Istat, Roma, 1983. (6) Istat, Conti economici nazionali, Anni 1960- 1983, Collana di informazioni, Anno VIII, n. 2, 1984. (7) P; Abba Lerner, An Analysis and a Suggestion for Dealing with inflationary Depression, in: Keiser Norman, cit. (8) Alessandra Nannei, Cinque anni di relazioni della Banca centrale, “Azimut”, n. 13. (9) P. Samuelson, Wage-Price Guideposts and the Need for Informal Controls in a Mixed Economy, in: Keiser Norman, cit. (10) Paolo Sylos-Labini, Oligopolio e progresso tecnico, Einaudi, 1964. (11) Paolo Sylos-Labini, Sindacati, inflazione e produttività, Laterza, 1972. (12) Ezio Tarantelli, Produttività del lavoro, salari e inflazione, in: F. Modigliani, E. Tarantelli, “Mercato del lavoro, distribuzione del reddito e consumi privati”, 11 Mulino, 1975. (13) Jack E. Triplett (a cura di), The Measurernent of Labor Cost, National Bureau of Economy Research, Studies in Income and Wealth n. 48, Cam bridge University Press, 1983. NOTE
[1]
AZIMUT – RIVISTA SINDACALE DI ECONOMIA, POLITICA, CULTURA – MILANO via
Tadino [2]Alcuni sostengono che l’inflazione è iniziata prima, nel 1970. Gli incrementi calcolati sui N.I. dei prezzi all’ingrossi ISTAT sono per i singoli anni rispettivamente: 1969, + 3,9%; 1970, + 7,3%; 1973, + 17%; 1974, +40,7%. Comunque, i primissimi aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi si sono avuti proprio nel 1970, a seguito della nota Conferenza di Teheran dei Paesi Opec, che per la prima volta concordarono una strategia comune. (Cf. A. Nannei, Il controllo delle risorse petrolifere, “Economia pubblica”, n. 2-3, 1971, e Il settore petrolifero: la situazione italiana, “Economia pubblica”, n. 4, 1971). È a questa inflazione d 1969-70 a cui si riferisce Ackley, cit. |