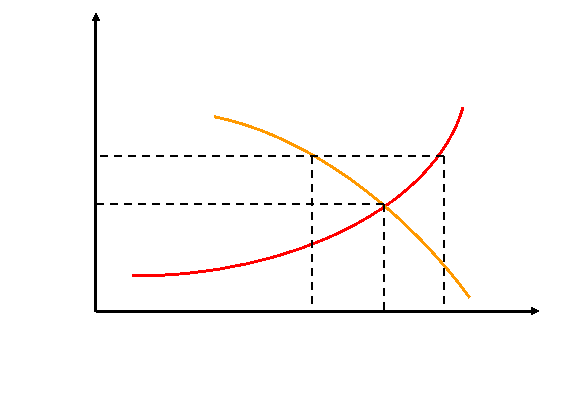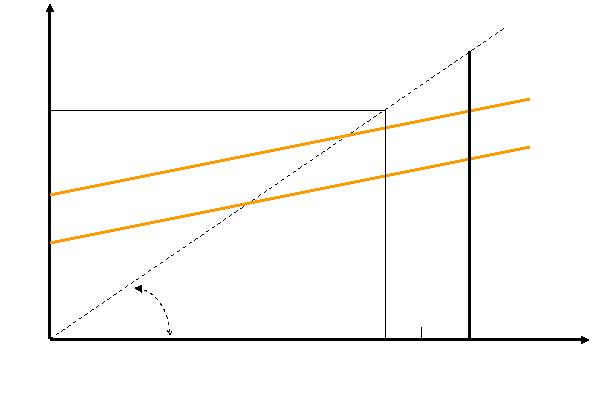|
TEORIE NEO
NEOCLASSICHE Appunti di un corso [1] Volendo cominciare a dare una prospettiva storica su questo avvento e resurrezione dei neoclassici, si può dire, osservando la storia del pensiero economico degli ultimi 50 anni, che lo stesso pensiero economico abbia compiuto un’evoluzione simile al percorso che si può effettuare seguendo la circonferenza di un cerchio. Si è iniziato negli anni ‘ 30, quando la teoria economica dominante e la politica economica che ne derivava erano neoclassiche, basate cioè su principi di liberismo e di laissez-faire assoluto (lo Stato non doveva assolutamente intervenire nel sistema economico perché questo possedeva già in sé gli automatismi sufficienti a raggiungere la posizione ottimale). Con la rivoluzione keynesiana questa idea di un sistema economico autosufficiente ed armonico è stata frantumata e a partire dagli anni ‘60 si è assistito per così dire ad una controrivoluzione per cui alla rivoluzione keynesiana si è opposta una rivoluzione monetarista propagandata soprattutto in America, a Chicago prima, e poi estesa rapidamente da Chicago alla Federal Reserve Bank degli Stati Uniti, poi alla Banca d’Inghilterra da parte di alcuni monetaristi e successivamente un po’ dovunque; tanto che oggi le ricette monetariste abbondano un po’ ovunque ed in Italia ad esempio alcuni economisti tendono verso il monetarismo nonostante il pensiero keynesiano sia ancora radicato. La ripresa del liberismo In linea di massima, dal punto di vista della politica economica, le idee monetariste sono classificabili come neo-classiche perché implicano un ritorno completo all’ortodossia neoclassica: cioè l’idea secondo la quale lo Stato deve assolutamente astenersi dall’influenzare la vita economica del sistema perché (e in ciò si può ravvisare un aspetto ancor più radicale rispetto alla forma neoclassica) provocherebbe più danni che benefici. Friedman sostiene che le fluttuazioni economiche che oggi noi osserviamo, l’inflazione, le crisi, sono proprio la conseguenza del tentativo dello Stato di influenzare l’attività economica seguendo i principi keynesiani: se lo Stato si astenesse completamente dal tentare di influenzare la vita economica si assisterebbe invece ad uno sviluppo del sistema economico che non avrebbe né sussulti, né strappi, quali noi conosciamo. Se ancora rimaniamo nel contesto storico e vogliamo giustificare con gli avvenimenti concreti nel sistema la rivoluzione keynesiana prima e la controrivoluzione neoclassica o monetarista poi, si può vedere che c’è una certa dose di verità nel fatto che ogni rivoluzione o controrivoluzione nasce in un certo senso dalle difficoltà, dalle crisi, dal fallimento della teoria precedente. La «svolta» keynesiana Così per esempio la cosiddetta rivoluzione keynesiana o comunque la politica economica keynesiana nasce dal fallimento della teoria neoclassica a trattare la grande depressione del ‘30. Le teorie keynesiane sono rappresentate soprattutto da un uso della spesa pubblica (sia della spesa per consumi, sia soprattutto della spesa per investimenti), per aumentare la domanda effettiva del sistema e quindi portare il sistema verso la massima occupazione, che era quello che si riteneva fosse il più grande problema delle economie capitalistiche negli anni ‘30 (cioè l’assenza di un livello di domanda di beni tale da poter arrivare alla piena occupazione). Negli anni ‘30 c’erano delle brillanti intuizioni ed anticipazioni ed economisti sia inglesi che americani sostenevano punti di vista simili a quelli che poi sarebbero stati propagandati come «l’ortodossia keynesiana», ma la vera applicazione su larga scala delle politiche economiche keynesiane si ha nel dopoguerra ed è proprio come conseguenza dell’applicazione delle teorie keynesiane e delle grandi spese americane all’estero che le economie capitalistiche hanno conosciuto nel secondo dopoguerra un tasso di sviluppo continuo ed elevato, mai conosciuto nei periodi precedenti. Paradossalmente, il successo stesso delle teorie keynesiane ha provocato o ha creato le condizioni per cui le stesse teorie keynesiane sono entrate in crisi: le idee keynesiane cioè, che erano quelle per cui si poteva controllare l’economia e spingerla verso la piena occupazione, hanno provocato come conseguenza il fatto che in quasi tutti i paesi, negli anni ‘60, si è arrivati sostanzialmente alla piena occupazione; la piena occupazione ha comportato tutti quei fenomeni sociali conosciuti, cioè acquisizione di posizioni di forza da parte sindacale, da un lato, e, soprattutto, il convincimento da parte dei governi che fosse sempre possibile attraverso l’uso delle stesse politiche keynesiane controllare completamente l’economia. Se si poteva utilizzare la spesa pubblica per l’espansione, altrettanto era possibile utilizzarla per provocare la recessione e quindi ottenere il risultato precedente. Questa politica è però entrata irrimediabilmente in crisi negli anni ‘60, nel senso che non era più pensabile, nelle mutate condizioni interne ed internazionali di ogni Paese, applicare una politica così rozza per controllare quello che da allora è diventato il fenomeno sociale più importante dell’economia capitalistica: il fenomeno dell’inflazione. Nella sua versione così ristretta e semplicistica, l’economia keynesiana era entrata in crisi e si è parlato sia di crisi delle politiche keynesiane, sia di crisi della teoria stessa che aveva generato queste politiche. Ecco che allora, anzitutto proprio negli Stati Uniti al tempo delle presidenze democratiche di Kennedy prima e di Johnson poi, in un contesto generale espansionistico e nell’impostazione ancora più espansionistica della presidenza Nixon, l’idea di poter utilizzare e di poter controllare (attraverso la domanda keynesiana e gli strumenti di derivazione keynesiana come la stessa politica dei redditi) l’inflazione, è fallita. Il monetarismo In questo contesto generale di fallimento delle politiche economiche keynesiane si è inserita la controrivoluzione monetarista la quale, partendo dal malcontento generale suscitato dall’inflazione, dall’incapacità delle politiche economiche correntemente adottate di controllare l’inflazione, ha anche innestato una critica teorica secondo la quale la teoria keynesiana era sbagliata; era sbagliata ed occorreva ritornare alla posizione pre-keynesiana, che diceva appunto che il sistema economico può — se lasciato funzionare da solo — raggiungere una allocazione efficiente delle risorse e che qualunque intervento esterno causa più danni che benefici. Questo è il contesto generale nel quale si muovono i recenti sviluppi sia teorici, sia di politica economica. Per comprendere meglio quali siano le tesi che da parte monetarista vengono avanzate, nonché il contesto teorico nel quale vengono formulate, conviene forse ripercorrere brevemente, a livello più approfondito, qual’era lo stato della teoria economica e quali erano le prescrizioni di politica economica che venivano avanzate prima di Keynes, qual’era il nocciolo della teoria keynesiana e conseguentemente qual’era la parte centrale della teoria e della politica economica keynesiana e quindi riprendere brevemente le principali obiezioni monetariste a questo schema. Il nocciolo centrale della teoria neoclassica, come era stata esposta prima di Keynes, era che il sistema economico era autoregolantesi, cioè possedeva in sé degli automatismi che gli permettevano in ogni momento di raggiungere la piena occupazione. Il punto su cui Keynes contesta la teoria neoclassica è sostanzialmente uno: il sistema non è in grado di occupare tutta la forza-lavoro disponibile nel sistema. Lo schema teorico secondo il quale per i neoclassici si arrivava sempre alla piena occupazione si basava sostanzialmente su due ipotesi fondamentali: l’idea che nel sistema ci fossero sempre delle condizioni di concorrenza perfetta e, in secondo luogo, l’idea a ciò correlata (che è una conseguenza immediata della concorrenza) che si dovesse sempre assicurare nel sistema una flessibilità dei prezzi e dei salari. Adesso vediamo meglio che cosa vuoi dire. Analizziamo la descrizione neoclassica del mercato del lavoro (vedi Grafico 1).
W = salario monetario P = livello generale dei prezzi W / P = salario reale N = numero lavoratori occupati DL = curva della domanda di lavoro correlata inversamente al salario reale SL = curva dell’offerta di lavoro crescente al crescere del salario reale OA = offerta di lavoro in più che i lavoratori ritengono conveniente con Wo OB = Domanda che gli imprenditori ritengono conveniente con salario Wo OA – OB = DISOCCUPAZIONE Per i neoclassici la domanda di lavoro è una funzione, cioè una relazione correlata inversamente al salario reale. Poichè la domanda di lavoro proviene dalle imprese, sono gli imprenditori che domandano lavoratori per poter produrre beni. Secondo questa teoria se il salario per lavoratore è alto, gli imprenditori saranno disposti ad assumere pochi lavoratori, viceversa se il salario scende potranno assumere più lavoratori pagandoli di meno e quindi ottenendo un margine di profitto più elevato. Invece l’offerta di lavoro, che proviene dai lavoratori che si offrono sul mercato del lavoro per poter lavorare, è una funzione che cresce al crescere del salario reale. L’idea che sottostante questa ipotesi neoclassica è che i lavoratori possono sempre scegliere se lavorare oppure no e che i lavoratori saranno disposti a lavorare di più o ad offrire più ore di lavoro soltanto se vengono pagati di più: perciò il numero dei lavoratori aumenta e le ore di lavoro aumentano se il salario reale aumenta. Nel Grafico 1 esiste un solo punto nel quale la domanda di lavoro e l’offerta di lavoro si incontrano: il punto N: questo si verifica per un numero di lavoratori pari a N* per un salario reale pari a W*. A questo punto possiamo introdurre due ipotesi fondamentali neoclassiche. Supponiamo, dicono i neoclassici, che per esempio il salario monetario sia più alto — cioè supponiamo per esempio di essere a un W, che deriva da un salario monetario più alto rispetto al salario di equilibrio W*. Poichè il salario è più alto ne deriverebbe che i lavoratori vorrebbero lavorare di più, per esempio offrirebbero una quantità (che chiamiamo OA) di lavoro, mentre gli imprenditori sono disposti, essendo il salario più alto, ad assumere meno persone (corrispondenti ad OB). Allora si vede che la differenza tra OA e OB misura quella che si può chiamare disoccupazione «involontaria», cioè in realtà la disoccupazione effettiva che c’è sul mercato: tutti coloro che vorrebbero lavorare, ma non sono assunti dagli imprenditori perché il salario è troppo alto, necessariamente rimangono disoccupati. Secondo questa teoria nel sistema economico avremmo due conseguenze: la prima è la disoccupazione provocata da un salario troppo elevato, la seconda è che per effetto dell’efficienza del sistema di mercato, nel senso che se non esistono degli ostacoli al libero funzionamento del sistema capitalistico, questa posizione disequilibrata non può permanere ma viene automaticamente eliminata dal funzionamento del mercato stesso. Situazione di mercato del lavoro con salari “troppo elevati” Supponiamo di essere proprio nella situazione descritta e che il salario sia «troppo» alto: conseguentemente che ci siano dei disoccupati e che perciò si reputi opportuno eliminare questa disoccupazione. I neoclassici sostengono che, supponendo due condizioni: che cioè ci sia una concorrenza perfetta nel sistema e, conseguentemente, che tutti i prezzi siano flessibili, muovendosi rispetto all’eccesso della domanda e dell’offerta, sul mercato del lavoro i salari cominceranno a scendere in conseguenza dell’eccesso di offerta di lavoratori. Per esempio cominciano a scendere dal livello W verso il basso, a livello W*. Man mano che il salario scende le imprese sono allora disposte ad assumere più lavoratori; d’altra parte man mano che il salario scende alcune persone si ritirano dal mercato del lavoro perché ritengono che sia più conveniente oziare che offrire lavoro ad un prezzo più basso, cosicché si raggiunge infine la posizione di equilibrio N. Se si osserva la posizione di equilibrio H, si constata che essa è di equilibrio nel senso che se il salario è W* sono esattamente occupati tutti quelli che a quel salario vogliono lavorare, e tutti i disoccupati sono quelli che a quel salario non sono disposti a lavorare: a quel salario quindi non c’è disoccupazione volontaria, né disoccupazione permanente. Questa è sostanzialmente la teoria neoclassica, il cui corollario è evidente: se c’è concorrenza, se c’è conseguentemente flessibilità dei prezzi, si arriva sempre alla piena occupazione; se si arriva alla piena occupazione allora bisogna eliminare tutti quegli ostacoli che impediscono di arrivare alla piena occupazione. La teoria della politica economica che discendeva da questo schema era ovvia: eliminare tutti gli elementi che erano di ostacolo all’esplicarsi della concorrenza. Per cui si diceva — e negli Stati Uniti fu un dogma — che la causa principale della disoccupazione era per esempio la presenza dei sindacati: i sindacati controllano il salario monetario, fanno diventare il salario monetario più rigido e così facendo impediscono al salario stesso di scendere a quel livello che sarebbe necessario per arrivare alla piena occupazione, per cui sarebbe nell’interesse stesso dei sindacati permettere che il salario diventasse flessibile, perché a un salario reale minore per occupato corrisponderebbe complessivamente un numero maggiore di occupati. La politica economica punta ad eliminare tutti gli ostacoli alla concorrenza, e naturalmente questo non vale soltanto sul mercato del lavoro ma su qualunque altro mercato. Le leggi americane anti-trust derivano da questa stessa impostazione liberista. Il problema della domanda C’era però un punto che questa teoria lasciava in sospeso: una volta stabilita la quantità di domanda e offerta di equilibrio sul mercato del lavoro, e conseguentemente determinata la quantità prodotta, ne deriva automaticamente che essa debba essere tutta venduta? Proprio a questo punto si inseriva la critica di Keynes alla teoria neoclassica. La teoria neoclassica sosteneva, citando Say, che qualunque offerta — cioè qualunque produzione di beni — avrebbe sempre trovato una domanda in grado di assorbirla. Questa legge faceva parte naturalmente dell’ordine naturale, dell’idea che il sistema economico capitalistico lasciato a se stesso avrebbe prodotto la piena occupazione, come conseguenza di quelle condizioni di concorrenza e di flessibilità dei prezzi. La critica di Keynes alla “Legge” di Say Alla legge di Say, secondo la quale la produzione necessariamente creava una domanda in grado di riassorbirla, Keynes invece proponeva il principio esattamente opposto — e in questo la sua teoria segnò una rivoluzione. Non era, come sosteneva Say, la produzione che creava la domanda, ma era vero esattamente il contrario. In realtà quello che le imprese riescono a vendere è determinato da quello che gli individui domandano: è la domanda effettiva di beni a determinare le capacità di produzione del sistema. Keynes, per dimostrare questa sua tesi, aveva proposto un semplice modello, un semplice schema per far vedere qual’era la quantità massima di beni che si potevano vendere (vedi Grafico 2).
C = consumi I = investimenti Y = reddito La domanda complessiva di beni si compone di due parti: una domanda di beni di consumo e una domanda di beni di investimento. Quindi la domanda complessiva è uguale alla domanda per consumi che proviene dalle famiglie e che a sua volta è determinata dal reddito (più le persone hanno reddito, più consumeranno) e da una domanda di beni di investimento che invece proviene dalle imprese e che costituisce l’aspetto più difficilmente valutabile e controllabile dell’economia capitalistica. Allora è chiaro che la produzione deve essere uguale alla domanda — cioè le imprese producono esattamente quello che è domandato nel sistema — e ne segue necessariamente che il livello della produzione (che a sua volta è uguale a quello del reddito, perché il valore della produzione viene poi distribuito come salario e come profitto) è uguale alla domanda, cioè alla domanda di consumi più investimenti. In pratica qui sta il nocciolo della teoria keynesiana: il livello di produzione del reddito in un sistema capitalistico è determinato, anche nel senso che è limitato, dalla domanda che sorge nello stesso sistema. Ora, come si vede nel Grafico 2, i consumi crescono al crescere del reddito, quindi si possono rappresentare mediante una retta che cresce al crescere del reddito: più il reddito aumenta, più i consumi aumentano. Se a questo consumo andiamo ad aggiungere l’investimento, abbiamo allora una retta della cosiddetta «domanda aggregata», cioè della domanda complessiva a livello del sistema, che ci dice esattamente quanta domanda c’è per ogni livello di reddito. Ora è evidente che, essendo la bisettrice una retta a 45° che equipara i segmenti sull’ascissa e sull’ordinata, ciò vuoi dire che è un luogo di riferimento nei senso che è l’insieme dei punti in cui la domanda è uguale al reddito. Nel Grafico 2 al punto DE di domanda corrisponde solo il reddito E se si realizza l’equilibrio sui mercato delle merci. Supponiamo ora che, ritornando al grafico 1, sul mercato dei lavoro la piena occupazione sia quella corrispondente all’occupazione di N* lavoratori; a questi lavoratori possiamo far corrispondere una quantità di beni prodotti pari ad esempio a Y*. Sul Grafico 2 si vede allora che se le imprese decidessero effettivamente di occupare quel numero di lavoratori N* e quindi producessero una quantità di beni esattamente pari a Y* e la immettessero sul mercato, non riuscirebbero a venderla: infatti la produzione sarebbe in questo caso pari al segmento AC, mentre la domanda sarebbe solo pari a AB. Ne segue necessariamente che la parte BC non sarebbe venduta. Keynes sostiene perciò che, anche ad un salario reale cosiddetto di equilibrio, alle imprese non servirebbe occupare N* lavoratori perché dalla loro occupazione otterrebbero una produzione che non riuscirebbero a vendere sul mercato: la quantità di beni BC rimarrebbe invenduta e se le imprese continuassero a produrre beni che non vendono, necessariamente ridurrebbero l’occupazione e perciò la produzione. L’occupazione e la produzione effettiva tornerebbero al livello inferiore YE che in questo senso si può definire di equilibrio, perché solo a quel punto la domanda è uguale alla produzione. Ma di che tipo di equilibrio si tratta? E’ un equilibrio con disoccupazione e questo lo si vede immediatamente perché se l’equilibrio che assicura la piena occupazione è quello corrispondente a Y*, qualsiasi punto a sinistra di AC implica una produzione minore di quella potenziale (cioè di piena occupazione). Questo schema keynesiano si prestava in maniera immediata e straordinariamente flessibile per essere utilizzato a fini di politica economica: di qui la sostanza della teoria keynesiana. Da essa si sviluppa la politica di sostegno alla domanda allo scopo di elevare il reddito e la occupazione. La teoria keynesiana e il pieno impiego, l’inflazione da domanda Che cosa diceva però la teoria keynesiana una volta che fosse raggiunta la piena occupazione? La teoria keynesiana rientrava nell’ambito della teoria neoclassica. Si diceva allora: supponiamo, per esempio, di essere arrivati effettivamente alla piena occupazione, cioè supponiamo che l’equilibrio del sistema sia tale che la domanda effettiva abbia provocato una produzione tale da arrivare alla piena occupazione. Adesso supponiamo di spingere il sistema oltre la piena occupazione e che quindi addirittura lo Stato, consciamente o inconsciamente, aumenti la spesa pubblica portando la domanda aggregata oltre la piena occupazione. É evidente che in questo caso il sistema tende ad andare ad un livello di reddito che è oltre quello che è il massimo praticabile nel sistema. La cosa è ovviamente impossibile, non si può andare oltre la quantità massima producibile nel sistema. Ci deve quindi essere un meccanismo che impedisce alla domanda effettiva di andare oltre la piena occupazione: il meccanismo è l’inflazione. Se la domanda è superiore a quella massima del sistema si scatena l’aumento dei prezzi. Si era diffusa perciò l’idea che, se si voleva avere un’occupazione più alta, si doveva anche sopportare un’inflazione più alta; se si voleva un’inflazione più bassa, di contro, si doveva accettare una occupazione più bassa. Si pensava che la teoria keynesiana fornisse una scelta tra inflazione e occupazione: una inflazione più alta era il prezzo che si doveva pagare per un’occupazione più alta e, contemporaneamente, un’inflazione più bassa la si poteva ottenere solo a prezzo di una occupazione più bassa. La disoccupazione era il prezzo che si doveva pagare per avere un’inflazione più bassa. Keynes e il problema dei salari Che cosa diceva infine Keynes sulle variazioni salariali? Keynes sosteneva che se i salari scendevano, come risultato di tale caduta non si sarebbe necessariamente arrivati alla piena occupazione. La risposta keynesiana è l’illustrazione delle conseguenze che una riduzione dei salari ha sul livello del reddito. Supponiamo che il reddito sia ad un livello più basso di quello di pieno impiego e supponiamo che valgano le condizioni di concorrenza dipinte dai neoclassici per cui i salari monetari possono scendere. Se i salari monetari scendono, allora le imprese possono essere indotte ad assumere più lavoratori, come sostengono i neoclassici, ma se però ne assumono di più, produrranno di più. Per esempio: supponiamo di provocare una caduta dei salari tale da indurre le imprese ad aumentare la produzione da Y1 a Y * che è il massimo possibile. Keynes si domanda se la maggior produzione ottenuta con la maggior occupazione sarà venduta. Osservando il Grafico 2 si vede che, mentre la produzione aumenta a Y * la domanda rimane sotto quel livello. In questo caso anche se si riducono i salari e conseguentemente le imprese aumentano l’occupazione, esse non troveranno sbocco per le merci aggiuntive prodotte. Perciò l’unica possibilità che hanno i salari di fare aumentare la produzione è se inducono ad aumentare la domanda. Per Keynes la risposta è negativa per una serie di considerazioni. Primo punto: se i salari si riducono, la distribuzione del reddito si sposta dai lavoratori agli imprenditori,dai salari ai profitti: come è noto, la propensione al consumo è più alta per i lavoratori che per i percettori di reddito non da lavoro dipendente, per cui se riduciamo il salario unitario è più probabile che la domanda per consumi invece di salire semmai scenda. Secondo punto: l’effetto sugli investimenti. La riduzione dei salari può indurre ad aumentare o meno gli investimenti? La risposta è controversa. Se per esempio, al ridursi dei salari, gli imprenditori ritengono che il costo del lavoro è più basso, in linea di principio potrebbero essere indotti ad investire di più: questa è una ragione che potrebbe far pensare ad un aumento degli investimenti. Ma ci sono anche ragioni opposte: se i salari si riducono, le imprese potrebbero essere indotte a pensare che si ridurranno ancor più in futuro, rinviando così nuove assunzioni. E ancora: se i salari si riducono diventa più conveniente impiegare più lavoro e meno capitale e quindi anche questa ragione va a sfavore degli investimenti. Inoltre se i salari si riducono i beni prodotti oggi entrano in concorrenza coi beni che saranno prodotti domani a un costo più basso: anche questa è una ragione che va a sfavore dell’investimento. Inoltre niente si può dire sull’aspetto centrale dell’investimento, ossia sulle aspettative: una riduzione cioè dei salari implica o meno la possibilità di vendere di più in futuro? Come sappiamo, gli imprenditori investono se pensano di poter vendere di più in futuro, e allora se lo consideriamo sotto questo aspetto diventa molto improbabile che una riduzione dei salari oggi, e dei salari domani, sia anche accompagnata nella mente degli imprenditori dalla possibilità di poter vendere di più in futuro. In questo senso c’è una contraddizione, se volete, di tipo marxiano all’interno del sistema capitalistico: mentre cioè la riduzione del salario è benefica per il singolo capitalista, non lo è per i capitalisti nel loro complesso, nel senso che mentre ogni imprenditore, riducendo il salario dei propri lavoratori, ottiene profitti più elevati e quindi ottiene un rendimento più elevato, la stessa cosa non gli va bene se è generalizzata a tutti i capitalisti, poiché ciò determina un calo della domanda di consumi. Quindi la conclusione di Keynes era che la riduzione dei salari non cambiava la domanda effettiva e, in linea di massima, se c’era una direzione possibile e probabile del cambiamento, quella era verso la diminuzione piuttosto che l’aumento della domanda. Questo lo induceva a ritenere che variazioni dei salari non sarebbero state accompagnate — come dicevano i neoclassici — da un aumento dell’occupazione e da un aumento della produzione che avrebbe portato il sistema nella posizione naturale, ma semmai variazioni dei salari sarebbero state accompagnate da cambiamenti uguali come direzione nella produzione e nell’occupazione: cioè più bassi salari, più bassa occupazione, più bassa produzione, più alta disoccupazione. Quindi semmai il rimedio era opposto. “L’effetto dei saldi reali di cassa”: una critica monetarista a Keynes C’era però un aspetto della questione, che è poi quello ripreso dai monetaristi per dedurre che Keynes ha sbagliato ed è il cosiddetto «effetto dei saldi reali di cassa». L’idea monetarista era questa: supponiamo, come i neoclassici, che esistano condizioni di concorrenza perfetta; se si riducono i salari allora valgono le ipotesi di Keynes: cioè si riducono i salari, la domanda effettiva non cambia, quindi le imprese continuano ad occupare le stesse persone di prima, però adesso il salario monetario si è ridotto. Allora se il salario si è ridotto e si vende la stessa quantità di beni di prima, ciò significa che i prezzi dovranno ridursi perché si produce la stessa quantità, i costi sono gli stessi di prima in termini reali e se le imprese devono avere lo stesso profitto di prima perché valgono le condizioni di concorrenza e se il salario in termini di moneta si è ridotto, anche il livello dei prezzi deve ridursi per riproporre le stesse condizioni. Questa era anche la conclusione di Keynes, che sosteneva che in definitiva in un’economia capitalistica il livello dei prezzi è funzione, cioè è determinato dai salari monetari. In altre parole, se i salari monetari si riducono, i prezzi si riducono e se i salari monetari aumentano i prezzi aumentano; anzi c’è una relazione molto diretta tra prezzi e salari, nel senso che i prezzi variano in proporzione (se si escludono altri componenti di costo, come per esempio le materie prime che qui non sono mai considerate) all’andamento dei salari. Questo elemento del ragionamento keynesiano — che poi vedremo è in un certo senso marginale — è la parte centrale della ripresa monetarista alla critica keynesiana. Si dice infatti, supponiamo che il salario monetario si riduca; allora, di conseguenza, il livello dei prezzi si riduce: ma se il livello dei prezzi si riduce allora ciò vuol dire che la stessa quantità di moneta M e in generale tutte le attività finanziarie che sono espresse in termini di moneta (titoli, obbligazioni, ricchezza finanziaria) posseggono un valore più elevato. Oggi la situazione è opposta: i depositi in banca ogni anno sono, in termini reali, il 20% in meno dell’anno precedente. Se applicate il ragionamento opposto, e quindi se i salari cadono e i prezzi cadono, la quantità reale, in termini reali, di tutte quelle attività finanziarie (moneta, titoli, obbligazioni, azioni stesse) che sono espresse in termini monetari aumentano di valore. Ciò ha a sua volta due effetti: da un lato, come diceva Keynes, il tasso di interesse si riduce perché la stessa quantità di moneta con livelli di prezzo più bassi diventa più abbondante, cosicché le banche avendo più moneta a disposizione, riducono l’interesse e quindi l’investimento aumenta; in secondo luogo, essendo la quantità di moneta aumentata, la gente si sente più ricca e così decide di consumare di più. E’ praticamente un processo meccanico: i salari si riducono, i prezzi si riducono; questo fa aumentare l’offerta reale di moneta. È evidente che, se questo processo funziona, allora i monetaristi hanno ragione: la teoria di Keynes è sbagliata. Infatti noi possiamo sempre sostenere che partendo (vedi Grafico 2) dal reddito Y1 è possibile produrre una riduzione dei salari talmente forte da provocare di conseguenza una proporzionale riduzione dei prezzi così forte da far aumentare il valore reale della quantità di moneta in maniera da generare uno spostamento verso l’alto della domanda ed ottenere la piena occupazione. Per quanto banale possa sembrare, questo è il nocciolo centrale della teoria monetarista: la teoria keynesiana, la teoria di Keynes era errata dal punto di vista teorico perché non ha tenuto conto di questo effetto dei saggi di cassa, nel senso degli stock di attività finanziarie possedute in termini reali. La gente possiede un certo stock di attività finanziarie (moneta, obbligazioni, titoli) che sono denominate moneta: se il livello dei prezzi sale o scende, il valore reale di questi sale o scende. Le premesse della tesi monetarista Se un sistema capitalistico non possiede elementi contrari alla concorrenza (come per esempio la rigidità dei salari monetari, la presenza di elementi monopolistici ecc.) allora la libera concorrenza instaura sempre la piena occupazione, perché è sempre possibile una deflazione sufficientemente alta da permettere un effetto dei saldi di cassa talmente cospicuo da arrivare alla piena occupazione. Ma se questo effetto vale, allora ciò significa che un sistema economico capitalistico non può permanere a lungo nella situazione keynesiana ma si muove continuamente verso la piena occupazione, permane cioè in situazioni di inefficienza descritte da Keynes solo se ci sono quegli elementi di rigidità, ma se dal sistema eliminiamo le rigidità (in particolar modo la rigidità dei salari monetari e dei prezzi) arriviamo sempre alla piena occupazione. Ma se questo è vero, noi dobbiamo sempre muoverci nell’ottica di un sistema che continuamente tende verso la piena occupazione. In realtà, secondo i monetaristi, la posizione su cui noi dobbiamo concentrarci non è quella di equilibrio di sottoccupazione, ma quella di pieno impiego perché la prima esiste solo temporaneamente a causa di salari alti: se il sistema di concorrenza funziona, si tende continuamente al pieno impiego. Viene così in pratica nuovamente recuperata in pieno l’ideologia neoclassica attraverso l’effetto e la considerazione congiunta della deflazione e dei saldi di cassa reali. Quindi, a livello teorico, dalla critica che era stata fatta alla teoria keynesiana, discendono due conclusioni. La prima è che la teoria keynesiana è sbagliata perché il sistema economico di mercato, se lasciato libero di funzionare, in virtù di questo meccanismo arriva automaticamente alla piena occupazione: ci metterà tempo, sarà un processo doloroso, perché i prezzi cadono e cadendo i prezzi aumenterà il valore dei debiti, alcune imprese non saranno più in grado di far fronte all’aumentato onere dei debiti e magari falliranno, e così via, però alla fine si arriva all’equilibrio. Questa è anche l’idea che sta nella formazione monetarista, secondo la quale il sistema economico capitalistico è stabile. Cosa significa stabile? Significa che ha una dinamica interna che gli consente di muoversi sempre attorno alla posizione di piena occupazione. Uno shock esogeno come l’aumento del prezzo del petrolio, per esempio, viene assorbito dal sistema capitalistico entro un certo periodo di tempo, riportandosi di nuovo verso la piena occupazione. La sintesi neo-classica di Keynes Il secondo punto è quello noto con l’espressione «sintesi neo-classica di Keynes». Cosa significa sintesi neoclassica di Keynes? Significa la sintesi fra la teoria neoclassica e la teoria keynesiana, ma non nel campo della teoria bensì in quello della politica economica. Se l’elemento che permette di arrivare alla piena occupazione è l’effetto dei saldi di cassa reali, e questo avverrebbe spontaneamente nel sistema di mercato se i salari flettono e quindi i prezzi si riducono, allora, dato che l’effetto dei saldi di cassa dipende da un rapporto tra la quantità di moneta e il livello dei prezzi, perché, invece di aspettare che i prezzi scendano, non si aumenta la quantità di moneta? Se noi facciamo aumentare la quantità di moneta otteniamo, a prezzi stabili o a prezzi non in diminuzione, lo stesso effetto che otterremmo aspettando la riduzione dei prezzi. Questa era la posizione per esempio assunta da Patinkyn e dai neoclassici americani negli anni ‘60: cioè, la teoria keynesiana è teoricamente errata, però è così straordinariamente utile dal punto di vista della politica economica che invece di aspettare che il sistema di mercato autonomamente arrivi alla piena occupazione lo si può stimolare aumentando l’offerta di moneta e provocando quegli effetti di saldi di cassa che il sistema otterrebbe comunque ma in tempi più lunghi. Il dibattito sulla “sintesi neo-classica di Keynes” Rispetto a questa impostazione ci sono due posizioni da esaminare, che sono le posizioni divergenti rispetto a questa sintesi neoclassica emergente in America negli anni ‘60. La prima è la contro risposta, cioè l’obiezione keynesiana sia teorica, sia empirica, alla validità di questo ragionamento neoclassico; la seconda, è la radicalizzazione neo-neoclassica di questo schema da parte dei monetaristi. La teoria keynesiana sostiene che questo processo (cioè il processo descritto dai neoclassici) non può funzionare né in teoria nè in pratica. In realtà questi fenomeni (riduzione dei salari, riduzione dei prezzi, aumento delle quantità) non avvengono in laboratorio, avvengono nel tempo concreto, nella realtà delle economie: ci sono delle imprese che producono, dei lavoratori che lavorano, delle persone che consumano e investono. Tutto questo processo diventa ragionevole se e solo se, per esempio, al cambiare dei salari e dei prezzi le aspettative di profitto rimangono immutate, ma questo è assolutamente l’elemento che non può rimanere immutato. E non solo per le aspettative di profitto, ma anche per le aspettative e le attese delle famiglie. Per esempio: se i salari e i prezzi scendono, ragionevolmente si può supporre che gli imprenditori non riterranno che la loro capacità di vendere rimanga immutata e quindi, anche con una riduzione dell’interesse, non segue necessariamente che gli investimenti aumenteranno, ed anzi, se le aspettative diventano più pessimistiche, è semmai possibile che gli investimenti cadano. Inoltre quando i salari e i prezzi scendono, lo schema neoclassico presuppone che tutti sono diventati più ricchi perché i prezzi sono più bassi e quindi possono acquistare di più, cosicché i consumi aumentano. Ma proviamo un attimo ad immaginare nel tempo reale che cosa può accadere alle imprese quando i prezzi scendono. Come è noto, le aziende normalmente prendono capitali a prestito e quindi si indebitano: se i prezzi continuano a scendere dovranno ripagare nel futuro debiti che sono stati contratti a valore reale più basso e che adesso è diventato più elevato. Cioè succede esattamente il contrario di quello che succede oggi con l’inflazione: con la deflazione aumenta l’onere dei debiti e se l’onere dei debiti aumenta è possibile — combinato al fatto che le quantità scambiate rimangono le stesse — che le imprese non riescano più a far fronte all’onere dei debiti. Se un’impresa che è sopraffatta dall’onere dei debiti fallisce diventano tutti più poveri; quindi non è vero che un po’ sono più ricchi e un po’ sono più poveri, perché diventano più poveri i creditori dell’impresa perché non possono più esigere i loro crediti; diventano più poveri gli impiegati dell’impresa che non sono più occupati. Quindi, considerato nel tempo reale, questo effetto positivo del «real balance effect», cioè dell’effetto dei saldi di cassa reali, diventa quanto mai insostenibile. Le posizioni keynesiane sulla sintesi neo-classica La critica keynesiana alla posizione della sintesi neo-classica, quindi alla posizione neo-classica americana, si può riassumere così: il «real balance effect» è teoricamente errato e soprattutto prescinde da un contesto temporale preciso, mentre noi dobbiamo ragionare per economie che sono inserite in un ben preciso instante temporale; cioè quando si tiene conto della successione causale, semmai è più probabile che si verifichi esattamente il contrario. In secondo luogo, riduzioni generalizzate dei salari sono un elemento destabilizzante del sistema, cioè non si può ragionare prescindendo completamente dalla storia passata e quindi non si può pensare di ridurre il livello dei salari monetari; anche perché poi riduzioni generalizzate dei salari monetari implicano riduzioni generalizzate dei prezzi e l’instabilità complessiva di tutti i mercati finanziari. Ciò significa che se si vuole che il mercato finanziario abbia un minimo di stabilità — come mostra l’esperienza storica — il livello dei salari monetari deve essere in un certo senso stabile. Quindi queste alternative sono sia teoricamente sia praticamente improponibili e allora si riconfermano tutte le idee keynesiane; se si vuole arrivare alla piena occupazione bisogna agire sulla domanda; se invece si vuole agire sulla inflazione allora occorrono strumenti diversi dal controllo della domanda e il rimedio keynesiano all’inflazione è notoriamente quello della politica dei redditi. Se infatti il livello dei prezzi dipende dal livello dei salari monetari, allora si possono controllare i prezzi solo controllando i salari monetari. Nelle versioni neo-keynesiane più moderne, in cui si accetta che il livello dei prezzi è totalmente svincolato dal livello della produzione, solo con una politica dei redditi è possibile avere un livello dei prezzi compatibile, un livello dei prezzi stabile, e quindi una politica dei redditi che permetta ai prezzi di essere stabili. Le tesi monetariste All’estremo opposto stanno i monetaristi i quali innanzitutto negano ogni validità alla politica dei redditi,in quanto introdurrebbe, nella logica del sistema di mercato, degli elementi distorsivi nell’allocazione delle risorse e quindi, in quanto tale, provocherebbe un’allocazione delle risorse diversa da quella che produce il mercato e perciò è inaccettabile. D’altra parte è tanto più inaccettabile in quanto il sistema autonomamente tende, per i motivi che si sono visti, alla posizione di piena occupazione. Se si evitano di considerare periodi temporali brevi di un anno, due anni, ma si fa un’analisi di più lungo periodo, 5-10 anni, le posizioni keynesiane sono destinate già ad essere eliminate dal sistema di mercato. Si riottengono così gli stessi risultati neoclassici. Il primo risultato è che la politica della spesa pubblica — che era per così dire il nocciolo della politica economica keynesiana — diventa assoluta mente inefficace e distorsiva perché, supponendo che i governi decidano di aumentare la spesa pubblica, temporaneamente si potranno anche avere gli effetti keynesiani, ma poiché il sistema tende già ad arrivare al pieno impiego, questi effetti non possono essere permanenti. Poiché il sistema tende ad andare oltre le sue possibilità fisiche, il risultato è quello di provocare inflazione. Con l’inflazione però il livello dei prezzi aumenta, cosìcché si produce il risultato esattamente opposto rispetto a quello dell’aumento dei saldi reali: se il livello dei prezzi aumenta, la quantità di moneta reale si riduce, i tassi di interesse salgono e perciò l’investimento scende. Se lo Stato persiste nel mantenere la spesa pubblica a livelli particolarmente alti, spiazza la spesa privata. Ossia, se lo Stato continuando ad emettere moneta o titoli pubblici continua a mantenere la spesa pubblica ad un alto livello, mentre esso è in grado di mantenere in termini reali la stessa spesa pubblica, per effetto dell’inflazione che genera, ridurrà, attraverso l’aumento dei tassi di interesse che provoca, il livello dell’investimento (soprattutto il livello d’investimento privato), e, in parte, il livello dei consumi. Quindi in definitiva la spesa pubblica, dato che il sistema si muove sempre attorno alla piena occupazione, non produce nessun effetto reale ma inefficienza perché l’aumento della spesa pubblica va a detrimento dell’investimento privato. Questo è, nella terminologia tecnica, quello che viene chiamato normalmente «effetto di spiazzamento», o anche nel. termine inglese «crowding out». In altre parole, la spesa pubblica elimina la spesa privata, si sostituisce ad essa; in quanto tale è del tutto incapace nel lungo periodo di far muovere il sistema verso la posizione di equilibrio. Quindi la politica fiscale, al contrario di quella keynesiana, è inefficace. E che dire della politica monetaria, cioè della manovra di offerta di moneta? E’ evidente, anche qui, che se si aumenta l’offerta di moneta, si produce ancora una volta la stessa situazione vista in precedenza: un aumento dell’offerta di moneta riduce temporaneamente l’interesse, fa aumentare l’investimento; però anche qui si va oltre le possibilità fisiche di produzione del sistema, per cui prima o poi si genera un aumento dei prezzi. Quando aumentano i prezzi, la quantità di moneta torna quella di prima. Perciò si ha, rispetto a prima, che variazioni nell’offerta di moneta non sono in grado di fare variare il reddito (perché questo è già al massimo), ma si traducono unicamente in una variazione proporzionale dei prezzi. Si hanno allora due conclusioni: la prima è che anche la politica monetaria, in un certo senso, è inefficace sul reddito così come la spesa pubblica è inefficace rispetto alla possibilità di produrre delle variazioni nel reddito. La spesa pubblica si sostituisce a quella privata; la quantità di moneta provoca variazioni solo proporzionali dei prezzi. La teoria neo-quantitativa della moneta Il secondo punto è quello implicito della cosiddetta « teoria quantitativa della moneta» o, come oggi si dice, «teoria neo-quantitativa»: visto che la spesa pubblica non può niente e alla fine provoca reddito uguale con diverse retribuzioni, tutto ciò che le autorità di politica economica possono fare è controllare l’offerta di moneta. E questo è un obiettivo alla loro portata; però variazioni nell’offerta di moneta fanno variare solo il livello dei prezzi. Questa è una conclusione apparentemente banale che però assume forza se si guarda dal punto di vista dell’inflazione, perché la stessa conclusione permette anche di dire questo: dato che variazioni nell’offerta di moneta generano variazione dei prezzi, secondo Friedman si può anche concludere che variazioni nell’offerta di moneta sono la condizione necessaria e sufficiente per ottenere variazioni di prezzi. In altre parole, sono condizione necessaria nel senso che se non si producono variazioni nell’offerta di moneta non si produce nessuna variazione nel livello dei prezzi; per esempio una politica fiscale espansiva non potrebbe verificarsi, cioè non potrebbe produrre nessun effetto, se non è anche accompagnata dall’offerta di moneta. Se non c’è aumento di offerta di moneta non c’è influenza sul livello dei prezzi; ed è d’altronde condizione sufficiente che lo Stato aumenti l’offerta perché si verifichi un aumento dei prezzi. NOTE [1] Appunti del corso “elementi di economia politica” tenuto nell’autunno del 1981 presso la FLM Milano dal Prof. Carlo Bianchi, non rivisti dall’autore |