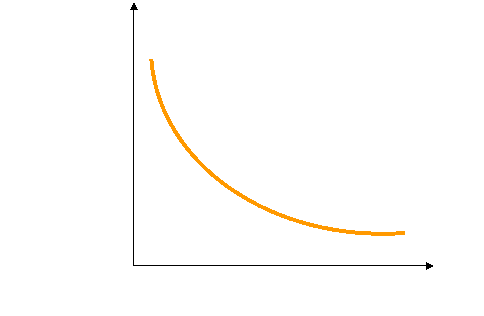|
LA
CRISI DEL KEYNESISMO Appunti di un corso [1] Si parla molto oggi di crisi del Keynesismo e delle politiche economiche keynesiane. A questo proposito, più che di crisi del pensiero economico di Keynes, si dovrebbe parlare di crisi di certe sue interpretazioni e soprattutto delle politiche economiche che a Keynes si sono richiamate anche se, come si vedrà, si sono allontanate in modo notevole dalle enunciazioni del celebre economista inglese. Per argomentare questa affermazione verranno toccati i seguenti punti: 1 - le indicazioni di politica economica derivanti dal pensiero neoclassico, 2 - le novità di Keynes ed il New Deal di Roosvelt, 3 - le politiche economiche che in modo più stretto hanno cercato di ispirarsi a Keynes, 4 - la loro crisi ed i motivi. La politica economica neoclassica Parlare di politica economica neoclassica può sembrare paradossale: una teoria economica che esalta la capacità del libero mercato di risolvere senza interventi esterni tutti i problemi non dovrebbe a rigor di logica, prevedere nessun intervento dello Stato. In realtà invece anche gli economisti neoclassici, dominatori assoluti della scena prima di Keynes, prevedevano che lo Stato avesse tre campi d’azione: - lotta ai monopoli privati, - redistribuzione del reddito attraverso l’imposizione progressiva, - offerta di alcuni beni pubblici che il mercato non è in grado di offrire (difesa, istruzione). Si prevedeva cioè che lo Stato intervenisse, rispettando rigorosamente il vincolo del pareggio di bilancio, in alcuni punti limitati dove il mercato si rivela inefficiente. L ‘elaborazione Keynesiana e il New Deal La parte fondamentale del pensiero di Keynes nasce subito dopo la 1° guerra mondiale, anche se la sua opera fondamentale (teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta) viene completata nel ‘36, dopo la grande crisi. Non si può dire però che il New Deal di Roosvelt sia ispirato a Keynes. Esso piuttosto deriva più da un sentimento popolare diffuso negli USA, che Roosvelt colse e fece suo. Del resto questo discorso è da considerarsi valido non solo nei confronti del New Dea!, ma anche rispetto ad altre linee di politica economica che a Keynes si sono ispirate anche in modo più esplicito. Infatti Keynes nei suoi scritti non confezionò mai “ricette” di politica economica precise: elaborò piuttosto una certa analisi finalizzata a risolvere, in un sistema capitalistico, il problema della piena occupazione, affermando che gli strumenti di intervento concreti andavano studiati caso per caso. Le principali novità analitiche del suo pensiero possono essere così sintetizzate: a) la piena occupazione non è affatto una situazione normale in un sistema capitalistico, anzi, la normalità è piuttosto la disoccupazione; b) la finanza pubblica va utilizzata, oltre che per i fini di maggior equità sociale, già in parte accettati dagli economisti neoclassici, anche per stimolare un aumento dei consumi e della domanda al fine di ottenere un pieno utilizzo delle risorse produttive e raggiungere così la piena occupazione; quindi forte progressività delle imposte dal lato delle entrate e bilancio dello Stato non necessariamente in pareggio dal lato delle uscite. e) Keynes, pur consapevole della grande importanza dei rapporti economici internazionali, ragiona come se si trovasse di fronte a un sistema economico chiuso; rispetto al sistema monetario internazionale egli sostenne infatti i cambi flessibili (che facilitano un più rapido aggiustamento delle bilance dei pagamenti), trovandosi così in minoranza alla conferenza di Bretton Woods che opta invece per i cambi fissi; d) Keynes ipotizza una rigidità verso il basso dei salari monetari ma non di quelli reali: dà per scontato dunque che, in presenza di tensioni inflazionistiche, i salari non riescano a recuperare interamente il proprio potere d’acquisto; e) infine Keynes afferma che in determinate situazioni di ristagno economico si possa attuare una politica monetaria espansiva per abbassare la propensione al risparmio e rilanciare così la domanda. Le politiche “Keynesiane” L’applicazione più vicina alle teorie keynesiane si ebbe negli anni ‘50 e ‘60 negli USA ed in Inghilterra. In queste applicazioni vennero però rimosse tutte le precauzioni di Keynes sulla politica economica. In particolare, per finanziare un maggior intervento dello Stato nell’economia, si aumentò il drenaggio fiscale non tanto attraverso una maggiore progressività delle aliquote, quanto innalzando l’aliquota media. Inoltre, dal punto di vista della spesa, si abbandonarono le indicazioni sulla qualità della spesa che Keynes aveva fornito, prendendo per valido quello che, nel suo ragionamento, era solo un paradosso (far scavare buche e poi farle riempire ai disoccupati). La grande espansione della spesa fu così indirizzata verso gli armamenti e la ricerca spaziale. Il grande sviluppo economico di quegli anni contribuì a far avanzare la convinzione dell’onnipotenza economica della spesa pubblica e della espansione monetaria. In realtà le ragioni dello straordinario sviluppo economico di quegli anni vanno ricercate nelle condizioni storiche ed economiche a livello mondiale del dopoguerra, più che nelle analisi di Keynes e nelle politiche economiche che a lui si richiamavano. Ne ricordiamo tre in particolare: 1 - l’armonia intercapitalistica del dopoguerra sotto il ruolo guida degli USA (che favorirono lo sviluppo dei partners occidentali) e la stabilità monetaria garantita, più che dal regime dei cambi fissi, dall’assoluta credibilità e stabilità del dollaro; 2 - il rapporto tra paesi industrializzati e paesi produttori di materie prime nettamente favorevole ai primi, fatto questo che garantiva l’approvvigionamento di materie prime e bassi costi; 3 - l’abbondanza di forza lavoro e la debolezza sindacale, che consentivano una politica di bassi salari. A queste condizioni probabilmente lo sviluppo ci sarebbe stato comunque, anche senza politiche Keynesiane. In ogni caso si generò in questi anni la convinzione che la politica economica era sempre in grado di controllare al meglio le variabili fondamentali del sistema: a - la occupazione, attraverso espansioni della spesa pubblica in periodi di ristagno; b - la inflazione, che si controllava automaticamente, essendo vero in quegli anni, come abbiamo visto, l’assunto Keynesiano di salari reali flessibili verso il basso; c - la bilancia dei pagamenti, attraverso aumenti dei saggi di interesse che permettevano di compensare eventuali deficit commerciali con attivi nei movimenti di capitale. Si giunse così a una situazione di quasi piena occupazione e iniziarono a manifestarsi le prime tensioni inflazionistiche. La curva di Philips Nel 1958 Philips teorizzò sulla base di rilevazioni statistiche empiriche, l’esistenza di una relazione inversa stabile tra salari/inflazione e disoccupazione.
In altre parole, dato un certo livello di disoccupazione, si determina automaticamente il saggio di inflazione. Perciò per ridurre l’inflazione è necessario accettare una maggior disoccupazione. Questa affermazione, come si è detto, non era sostenuta da alcuna proposizione teorica ma solo da rilevazioni statistiche di lungo periodo. Ciò nonostante fu adottata in parecchi documenti ufficiali di politica economica (ad esempio dalla Banca d’Italia dal 1969 in poi). Fu successivamente abbandonata quando le stesse rilevazioni empiriche la smentirono, ossia quando negli anni 70 inflazione e disoccupazione aumentarono contemporaneamente. La crisi del Keynesismo Come le fortune di Keynes dipesero in buona parte dalle eccezionali condizioni storiche ed economiche degli anni ‘50 e ‘60 ricordate sopra, così la crisi del Keynesismo deriva dalla crisi dei cardini su cui si è fondato lo sviluppo economico del dopoguerra. 1 - Crisi del rapporto fra paesi industriali e produttori di materie prime: tra il ‘73 e il 1980 il prezzo del petrolio è praticamente indicizzato. 2 - Fine della debolezza contrattuale della forza lavoro dovuta al raggiungimento della quasi piena occupazione ed al conseguente rafforzamento dei movimenti sindacali. Si arriva così a un periodo caratterizzato da stagnazione con inflazione. Si tratta di inflazione da costi derivante, in ultima analisi, dal disaccordo sulla distribuzione del reddito internazionale. Di fronte a questa situazione la “ricetta” più fedele all’analisi Keynesiana è: a - perseguimento della piena occupazione attraverso un aumento selezionato della spesa pubblica; b - lotta all’inflazione attraverso la politica dei redditi; c - per quanto riguarda le bilance dei pagamenti, in deficit: svalutazione (nel breve periodo), accompagnata da rialzi nei tassi di interesse, ma soprattutto (nel lungo periodo) profonda riforma del sistema monetario internazionale. Questo in teoria. Nella pratica però questa ricetta incontra più di un ostacolo. Quello maggiore è l’affermazione negli USA e in Inghilterra di teorie e politiche economiche monetariste che indicano nell’eccessiva espansione della offerta di moneta la causa dell’inflazione e praticano di conseguenza politiche di restrizione monetaria con alti tassi di interesse. Questo costringe gli altri paesi ad adeguare i propri tassi di interesse a quel livello rendendo impraticabile un loro ulteriore aumento finalizzato a pareggiare le bilance dei pagamenti in deficit e impedisce anche significative dilatazioni di spesa e deficit pubblico (per combattere la disoccupazione), già gonfiati dagli interessi che lo Stato deve pagare ai propri creditori. Un ulteriore effetto negativo di queste politiche è la depressione col conseguente aumento della disoccupazione. Reagan e la Tatcher hanno ottenuto notevoli successi nella lotta all’inflazione pagandoli con tassi di disoccupazione elevatissimi. Non vi sono però certezze sul fatto che il passaggio alla seconda fase del loro programma (volta allo sviluppo economico e alla ripresa occupazionale) l’inflazione non possa riprendere a galoppare. Un altro ostacolo alla realizzazione di queste politiche Keynesiane è la resistenza sindacale ad accettare la politica dei redditi, visto che questa si è quasi sempre rivelata incapace di controllare i prezzi oltre che i salari. La situazione si presenta dunque di paralisi. Ogni intervento di politica economica rischia di risolvere un problema vecchio aprendone contemporaneamente uno nuovo. L’unica strada, almeno nel breve periodo, appare il piccolo cabotaggio, in attesa che l’avvicinarsi delle elezioni in USA (1984) rilanci il cosiddetto ciclo politico, cioè l’adozione di politiche espansive che rilancino lo sviluppo dell’economia statunitense che si trascinerebbe dietro le altre. NOTE [1] Appunti del corso “L’eredità di Keynes” tenuto presso la FLM Lombardia dal Prof. Carlo Bianchi (Università di Pavia) nei primi anni ’80, non rivisti dall’autore |