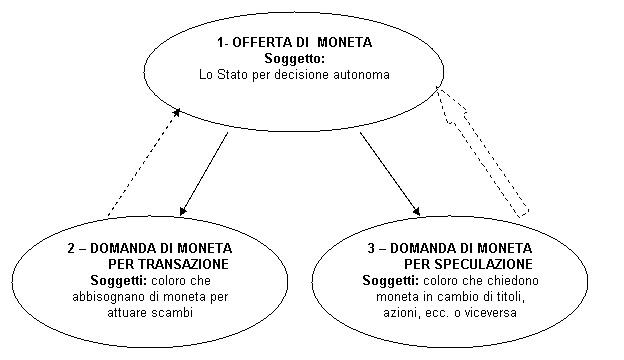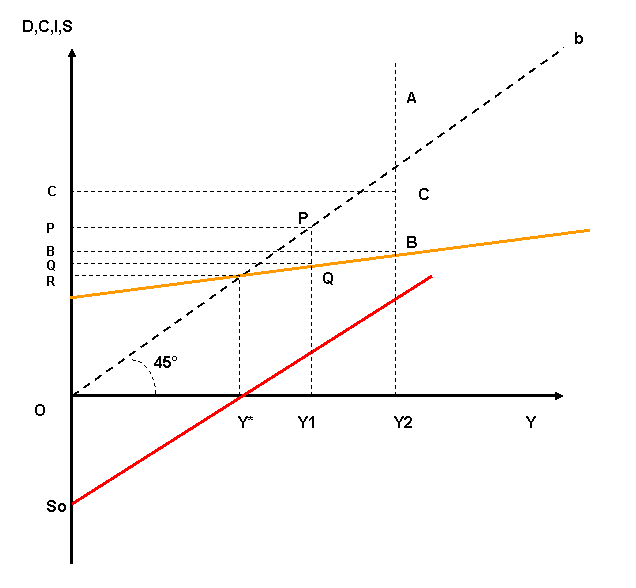|
I
CLASSICI, MARX, I NEOCLASSICI E KEYNES: Appunti di un corso [1] PREMESSA In questa lezione si affronterà e porrà a confronto i quattro schemi teorici di base prodotti dall’economia politica dall’inizio dello sviluppo capitalistico fino ad oggi. In sintesi le grandi visioni del sistema economico che si considereranno sono: il pensiero classico, il pensiero marxiano, il pensiero neoclassico e il pensiero keynesiano. Poichè si tratterà di una sintesi, si procederà in maniera molto schematica. In questa maniera si potranno così meglio evidenziare alcuni aspetti e confrontare questi schemi fra loro. La premessa è che un tale riassunto di schemi non vuol essere un omaggio alla storia: non si tratta solo di schemi di cui alcuni sono vecchi, altri recenti, alcuni utili, altri futili, bensì di schemi teorici che costituiscono delle alternative a cui si ispirano ancor oggi persone, economisti, politici nelle loro scelte. Anche si tratta di quattro schemi che si contrappongono, non bisogna meravigliarsi di questo fatto, dato che ciò accade in tutte le scienze: non esiste infatti in nessuna scienza, neanche nella più perfetta e anche nella più precisa, un’unica teoria, ma esistono visioni alternative. A maggior ragione nell’economia. Un altro elemento di premessa: non si può contrapporre in maniera molto semplice, come qualcuno fa, Marx da un lato e il “pensiero borghese” dall’altro. È troppo semplice, poiché certamente c’è il pensiero di Marx che si contrappone ad altri pensieri economici che non sono affatto omogenei e compatti tra loro: infatti i tre schemi borghesi che verranno accostati a quello di Marx — lo schema classico, lo schema neoclassico e lo schema keynesiano — sono profondamente diversi fra di loro. Si deve altresì constatare che l’economia borghese è in lotta feroce al suo interno; essa pretende magari di assurgere a scienza universale, unica per tutti, pur tuttavia gli economisti, che per semplicità potremmo definire “borghesi”, hanno prodotto visioni alternative. In opposizione dello schema marxiano non c’è dunque un’unica teoria borghese, ma diverse teorie borghesi. Per esaminare questi schemi teorici, per confrontarli, si seguirà questa strada: si analizzerà in un primo momento il sistema economico sotto una certa ottica, e, poi, in un secondo momento sotto un’altra ottica. I due procedimenti di lettura rappresentano due modi diversi di vedere il sistema economico. Si seguirà questa via per fornire anche alcuni elementi essenziali su ciascuna teoria. Dapprima si considererà il sistema economico diviso per mercati e, in particolare, il sistema economico suddiviso in mercato del lavoro, mercato delle merci, mercato della moneta. Per mercato del lavoro si intende l’offerta da parte dei lavoratori e la domanda da parte delle imprese di lavoro; per mercato delle merci si intende tutto ciò che è prodotto e quindi non soltanto le merci di consumo ma anche i beni di investimento; l’altro mercato è quello della moneta o in termini più ampi, il mercato monetario e finanziario,anche se in questo lavoro ci si limiterà a considerare la moneta. In ognuno di questi mercati agiscono degli attori principali. Nel mercato del lavoro agiscono capitalisti e lavoratori. Nel mercato delle merci gli attori sono sempre capitalisti e lavoratori ma l’occhio viene posto sulla produzione delle merci che possono essere di due tipi: merci di consumo e merci di investimento. Nel mercato della moneta emerge tra altri un attore molto particolare: lo Stato, perché è l’unico autorizzato a stampare moneta; da una parte quindi c’è lo Stato che offre la moneta al sistema e dall’altra parte ci sono tutti gli altri che usano moneta, sia lavoratori, sia capitalisti. In questa lettura di tipo “verticale” verranno analizzati i tre mercati: quello del lavoro, delle merci e della moneta, e, per ognuno di essi, le quattro teorie in modo da evidenziare le differenze. Con un’altra lettura del sistema economico, di tipo “orizzontale”, si prenderà in esame la produzione, la distribuzione e la domanda. Si analizzerà come si producono le merci, come si distribuisce il prodotto nazionale e come questo prodotto nazionale viene utilizzato. 1 - IL PENSIERO CLASSICO In questa parte verrà riassunto il pensiero classico secondo la griglia sopra esposta. Anzitutto si fa presente che in realtà non esiste “il pensiero classico”, bensì diverse teorie classiche: c’è Smith, c’è Ricardo, c’è Malthus ecc. In questo lavoro ci si riferirà in particolare a Ricardo, come suo massimo esponente. E’ chiaro che così facendo si opera una riduzione, ma Ricardo è senz’altro l’economista più rappresentativo del pensiero classico. Il mercato del lavoro, delle merci e della moneta Il mercato del lavoro Il mercato del lavoro viene visto da Ricardo come un momento del sistema indipendente dal resto, come se fosse un mondo a sé stante che non dipende da quello che accade nel resto del sistema. Nel mercato del lavoro ci sono lavoratori che chiedono un posto di lavoro e un salario, e capitalisti che assumono lavoratori per impiegarli nella produzione dando loro in cambio un salario. Sembra una visione banale ma essa presuppone l’esistenza di una condizione particolare: i lavoratori chiedono di lavorare perché non hanno mezzi di sussistenza e chiedono un salario perché devono sopravvivere con le loro famiglie. Nell’ambito del mercato del lavoro domina quindi il concetto di sussistenza: i lavoratori che non hanno i mezzi della produzione, devono sopravvivere e l’unico modo per farlo è quello di poter vendere la propria forza lavoro ad un capitalista. Si comprende che se tutto è legato al concetto di sopravvivenza del lavoratore, ciò che accade al di fuori non serve a niente: che vada bene o che vada male, il problema del lavoratore è quello di sopravvivere e il problema che domina sul mercato del lavoro è dunque quello del salario di sussistenza. Dietro a questa visione c’è il concetto classico dell’accumulazione che si innesta sulle vicende del mercato del lavoro. Se i lavoratori, per caso, riescono ad avere un salario reale superiore alla sussistenza, succede che la popolazione aumenta e il salario si abbasserà. Viceversa, se il salario è al di sotto del minimo di sussistenza, diminuiranno la popolazione e l’offerta di lavoro e il salario salirà ai livelli di sussistenza. In questo mercato quello che perciò conta è, da un lato, il concetto di sopravvivenza e, dall’altro, l’esistenza di meccanismi “naturali”. Il mercato del lavoro risulta “a parte” perché è dominato dalla legge della popolazione e cioè da una legge demografica, non economica. Secondo questa legge demografica tanto più alto è il salario, tanto più alta sarà la popolazione, ma tanto maggiore diviene l’offerta di lavoro tanto più basso sarà il salario. La produzione può aumentare o può diminuire, ma ciò non ha effetti sul mercato del lavoro poiché ivi domina una legge di natura e domina il concetto di sussistenza. In tale impostazione teorica il salario è una «variabile indipendente »; il salario infatti non dipende da quello che accade altrove, non dipende dalla produttività, né dalla produzione, né dalle scelte del capitalista, né dall’equilibrio del sistema. Il salario, in quanto è legato a un problema di sussistenza del lavoratore e a sua volta condizionato da problemi di natura (la crescita della popolazione), è una «variabile indipendente» del sistema. Questo è un punto forte di questa teoria. Il mercato delle merci Nella visione classica nel mercato delle merci agiscono i capitalisti cha hanno assunto i lavoratori e producono merci per il consumo e l’investimento. Caratteristica di questo mercato è che la produzione delle merci è una produzione che si espande di continuo perché i capitalisti svolgono un ruolo molto preciso che è quello di fare investimenti, allargare la produzione, allargare l’occupazione. Il loro ruolo, nella visione dei classici, è quello di produrre più merci: le merci di investimento saranno utilizzate per allargare ancora la produzione, quelle di consumo dovrebbero servire (lo dice chiaramente Ricardo) a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Quindi nel mercato delle merci si afferma questa funzione propulsiva del capitalista che investe e che mira ad un allargamento continuo della produzione. Rimane però un limite molto preciso: anche qui agiscono leggi naturali che frenano lo sviluppo, lo rallentano fino al punto in cui l’economia non si svilupperà più. Da questo punto di vista i classici hanno chiaramente in mente il limite del sistema capitalistico, un limite che è dettato, per l’appunto, da una legge naturale. In particolare la legge naturale a cui pensa Ricardo è quella dei rendimenti decrescenti della terra: tanto più cresce e si espande il sistema, tanto più occorrerà mettere a coltura terre via via meno fertili ottenendo però una crescita della produzione non proporzionale, in diminuzione. Questo significa che le merci che vengono prodotte dall’agricoltura, ossia i viveri di sussistenza, sono merci che diventano sempre più care, sempre più costose. Ne consegue che se aumenta il costo del lavoro, ciò non dovuto al fatto che i lavoratori vogliono di più, ma per una legge di natura connessa al fatto che si andrà incontro a sempre maggiori difficoltà di produzione. Ma questo genera un altro fenomeno: le terre via via meno fertili messe a coltura rendono più appetibili, più desiderabili, dal lato del capitalista, le terre più fertili perché lì egli potrebbe guadagnare di più: si scatena allora la concorrenza fra i capitalisti per le terre più fertili cosicché si arriva alla formazione della rendita, che è una parte del prodotto che viene tolta agli stessi capitalisti a causa della loro competizione a vantaggio di una classe passiva, che è la classe dei proprietari terrieri i quali godono del vantaggio di prendersi via via rendite sempre maggiori destinandole al consumo ma sottraendo risorse alla accumulazione. Nella visione classica il sistema procede nell’espansione ma essa diventerà sempre più lenta perchè in presenza di rendimento sempre più basso delle terre le merci di sussistenza diventano sempre più care, per cui cresce il costo del lavoro, sia perchè a causa della concorrenza fra capitalisti per accaparrarsi le terre più fertili, una parte crescente del prodotto sociale del sistema sarà presa dai proprietari terrieri e tolta all’accumulazione, cosicché si investirà sempre meno fin quando il sistema, rallentando , arriverà a uno stadio stazionario in cui l’espansione sarà frenata. Della concezione classica va sottolineata anche la distinzione tra merci per la sopravvivenza ed altri prodotti. Noi oggi pensiamo in genere a tutta una serie di beni a nostra disposizione televisore, automobile, i viaggi, come beni indifferenziati, ma nel mondo classico si faceva una distinzione molto precisa tra merci che servono per vivere — che poi sono il pane, ma anche il vestito, cioè tutto quello che in qualche modo è legato alle risorse direttamente offerte dalla natura (la terra per il grano, le miniere per il carbone; ecc.) — da altri beni che erano meno essenziali. Questa distinzione si è persa in seguito, ma allora si distinguevano nella massa delle merci due tipi: le «necessities», cioè i beni necessari a vivere, dalle «commodities», cioè le cose comode, le cose diverse da quelle necessarie ma che accrescevano lo standard di vita. Le «necessities» si ottengono dalla terra che è via via meno fertile e per questo darà sempre meno. Per gli economisti classici, per quanto ci sia progresso tecnico, per quanto si migliorino i fertilizzanti, le macchine in agricoltura, per quanto si migliorino i metodi per estrarre il ferro o il carbone dalle miniere, il progresso tecnico non riuscirà mai a contrastare il limite di una scarsità delle risorse naturali. A seguito della crescita della scarsità delle risorse naturali, scarsità non controbilanciata dalla introduzione di nuove tecniche di produzione, le merci da esse ricavate diverranno più care, di questo fatto si avvantaggeranno i proprietari terrieri, ovvero i detentori di rendite, il cui ruolo non è quello di investire nè quello di concorrere alla espansione del sistema. Ricardo, in questa analisi, coglie l’aspetto parassitario della classe dei «rentiers» rispetto all’accumulazione, ma gli sfugge la relazione di questa classe rispetto alla domanda. Se è vero che i proprietari terrieri portano via una parte del prodotto, è pur vero che questa parte la consumano, costituendo così una domanda di merci, una domanda per la stessa produzione: se i proprietari terrieri scomparissero, ci sarebbe meno domanda, si produrrebbe di meno e si avrebbe meno occupazione. Quindi non è detto che la loro funzione sia negativa dal punto di vista della domanda, anche se neppure va affermato che sia positiva. Come vengono prodotte le merci? Il problema delle tecniche di produzione I classici e Ricardo in particolare, considerano le tecniche come un dato. Il modo in cui si produce non riguarda l’economista. Si vedrà invece che nello schema neoclassico il problema della scelta della migliore tecnica diventa interno all’economia. Per i classici il problema della tecnica di produzione è estraneo: tutto ciò che è tecnica è un dato esterno; sì suppone che il produttore abbia scelto la tecnica migliore e con essa abbia prodotto le sue merci. L’uso delle merci Nella visione classica l’uso delle merci è molto chiaro: siccome si producono merci per il consumo e merci per l’investimento, ecco che allora la parte di merci che va al consumo andrà alle persone che devono consumare. Chi sono? I lavoratori in primo luogo. Partecipano quindi a questo mercato i lavoratori perché devono avere le merci che consumano per vivere con le proprie famiglie, in quanto merci di sussistenza. Poichè essi ricevono solo quanto è strettamente necessario per vivere (sussistenza), non possono risparmiare. Poiché il consumo dei lavoratori è per la sopravvivenza, esso viene chiamato «consumo necessario», necessario per ricostituire la propria forza-lavoro, per ritornare il giorno dopo a lavorare, mantenendo invariate le proprie prestazioni. Un’altra quota delle merci prodotte va ai proprietari terrieri, ai rentiers: questi consumeranno anche loro, ma consumeranno beni di lusso. Quindi nella massa delle merci prodotte dal sistema ogni anno si distingueranno i beni di consumo che vanno alle persone in beni di consumo necessari per la sopravvivenza dei lavoratori e in beni di lusso che vanno a soddisfare i bisogni dei proprietari terrieri. Anche la classe dei capitalisti certamente consuma perché anch’essi devono vivere, ma nella visione classica la loro funzione essenziale è quella di investire, di espandere la accumulazione. Allora se sul mercato delle merci si producono merci di consumo e di investimento, queste ultime sono comprate dai capitalisti, grazie ai loro risparmi, per allargare la produzione. In questo schema si ha che sul mercato delle merci c’è: · il consumo dei lavoratori, senza risparmio, · il consumo di lusso dei rentiers i quali anch’essi non risparmiano, · il risparmio dei capitalisti, i quali non consumano tutto il reddito ma risparmiano e investono il proprio profitto. Il mercato della moneta Il mercato della moneta, nella visione classica, non ha grande importanza: la moneta serve soltanto per consentire gli scambi ad ogni livello. I salari non si pagano in natura ma si pagano in moneta, cosicché il capitalista darà moneta al lavoratore che comprerà merci. I profitti di cui si appropria il capitalista non sono in natura, bensì in denaro. Così pure il proprietario terriero quando ottiene la rendita riceve denaro. Il fatto è che il denaro che va al salario, al profitto e alla rendita è soltanto un controvalore di merci: il suo uso deriva dal bisogno sociale di disporre di un mezzo universale per favorire gli scambi. Esso non ha altra funzione. Sul mercato gli scambi, il pagamento delle merci (acquisto e vendita), i pagamenti dei salari, dei profitti e delle rendite, sono fatti in moneta, poiché non si fa un baratto di merci contro merci. In questa visione la moneta serve solo per consentire questi scambi, serve soltanto come mezzo per agevolare lo scambio. Quindi in pratica, dentro il sistema, il mercato della moneta non conta niente, non avendo altra funzione che quella di consentire gli scambi. Al posto della moneta si potrebbe usare qualsiasi altro mezzo purché si sia d’accordo di usarlo come mezzo di scambio. Sotto questo punto di vista è come se ci si trovasse entro un’economia di baratto, dove si scambiano merci contro merci. Per Marx questo non corrispondeva al vero e così pure per Keynes, dato che per essi la moneta svolge un ruolo molto importante essendo una riserva di valore. Da ciò, secondo Marx e Keynes, possono venire stimoli alla crisi. Ma in questo mondo degli economisti classici la moneta non ha queste funzioni, ha solo la funzione di scambio, tant’è che il mercato della moneta potrebbe essere trascurato, quasi come un mondo che non esiste. Da tutto questo ne consegue che i tre mercati, considerati nel complesso, sono indipendenti. Il lavoro segue leggi sue (leggi di natura), il mercato delle merci è regolato, da un lato da leggi di natura (i rendimenti decrescenti della terra) e dall’altro da comportamenti di classe molto chiari (i lavoratori devono necessariamente consumare tutto quello che hanno ricevuto per sopravvivere; i rentiers devono necessariamente spendere i loro redditi; i capitalisti risparmiano e investono perché quella è la loro funzione sociale). Ecco che allora mettendo insieme questi tre mercati indipendenti (quello della moneta addirittura non conta) emerge un sistema che tenderà a finire in modo armonico, per semplice arresto naturale e non in seguito a conflitti. Non c’è cioè nessun problema di crisi all’interno, così come viene intesa oggi: crisi di disoccupazione, crisi di merci invendute ecc. Questi elementi di crisi non ci sono ed il sistema avrà la sua crisi finale a seguito del ristagno naturale, lento, insensibile, seppure inevitabile. Nel frattempo i comportamenti dei diversi attori sono ben definiti e chiari, tutto procede secondo regole armoniche. Produzione, distribuzione, domanda di merci Se questa è la ricostruzione del pensiero classico per quanto riguarda il mercato del lavoro, delle merci e della moneta, ora questa teoria verrà applicata per la lettura che viene data alla produzione, distribuzione e domanda di merci. La produzione Nel mondo classico la sfera della produzione non è altro che il luogo in cui i lavoratori, grazie ai mezzi di produzione dati dai capitalisti, producono le merci secondo tecniche che sono considerate date. Tali tecniche miglioreranno portando ad aumenti della produzione, che però saranno via via più ridotti. I classici non prevedono una riduzione della produzione ma un rallentamento della accumulazione e, da un certo punto in poi, il ristagno, la non espansione del prodotto sociale. Questa è quindi la loro visione della produzione: lavoro, accanto ai mezzi di produzione dei capitalisti, condizionato dalla legge di natura che farà sì che questa produzione raggiungerà un limite oltre il quale l’accumulazione non aumenterà. La produzione è vista come un fatto tecnico: vi partecipano i lavoratori, le terre di minor fertilità, i mezzi di produzione del capitalista, i quali nell’insieme concorrono a produrre, ed il tutto è condizionato da leggi di natura. La distribuzione Il prodotto, una volta ottenuto, si divide in salari, profitti e rendite. Più sopra abbiamo visto che:
A proposito della distribuzione, i classici danno quindi tre spiegazioni, una per ognuna di queste grandezze diverse: · il salario dipende dalla sussistenza, · la rendita deriva dal fatto che si mettono a coltura terre via via meno fertili, · il profitto è semplicemente ciò che resta in mano al capitalista. La domanda di merci Abbiamo già visto che le merci vengono utilizzate per consumi o per investimenti. I consumi sono quelli dei lavoratori e dei rentiers, gli uni in quanto beni necessari e gli altri in quanto beni di lusso. Il consumo c’è sempre automaticamente, così come c’e sempre l’investimento perchè i capitalisti reinvestono sempre ed automaticamente i loro profitti: da questo punto di vista non ci sarà mai possibilità di crisi dal lato della domanda, non ci saranno problemi, non ci saranno merci invendute. Poichè il consumo è consumo necessario e consumo di lusso, sia i lavoratori che i rentiers spendono tutto il loro reddito e gli investimenti ci saranno sempre tutte le volte che ci sono profitti, dato che se c’è profitto esso viene risparmiato, non consumato e perciò investito. Questa è la visione classica che è stata ripresa e in qualche modo adattata dallo schema di Sraffa e dai neoricardiani. Questo schema solleva dei problemi attorno alla sussistenza dei lavoratori, alla fine del capitalismo, al fatto se l’investimento sia automatico o meno (alcuni economisti sostengono che è automatico anche oggi). Comunque questo schema non viene mai ripreso così in toto dagli economisti classici, dato che viene privilegiata l’interpretazione che ne ha dato Sraffa. 2 - IL PENSIERO MARXIANO Se nel mondo classico i tre mercati erano indipendenti, per Marx i tre mercati sono invece interdipendenti, sono cioè collegati: il mercato del lavoro è collegato a quello delle merci e a quello della moneta; il mercato della moneta a sua volta non è affatto un mercato privo di incidenza, anzi, è uno dei mercati che conta di più insieme agli altri, essendo il luogo in cui si creano le premesse per cui si genera la crisi. Per Marx questi tre mercati sono interdipendenti sono però subordinati alla sfera della produzione. Mentre nel mondo classico la produzione è un fatto tecnico, nel mondo di Marx i tre mercati sono collegati e tutto quello che accade su questi mercati è subordinato a un ambito molto più importante, che è appunto la sfera della produzione. E’ infatti nella sfera della produzione che si genera il plusvalore ed è lì che si produce e riproduce il sistema capitalistico. Il sistema capitalistico non si definisce per quello che accade sul mercato del lavoro, né per quello che accade sul mercato delle merci e neanche per quello che accade sul mercato della moneta: si definisce perché nella sfera della produzione, una volta che il lavoratore è stato assunto, giocando sulla distinzione fra lavoro e forza-lavoro, si genera il plusvalore. A sua volta il plusvalore prodotto si tradurrà, mediante la sua realizzazione in danaro, in profitto ed il profitto avrà una certa destinazione e servirà a comprare o non comprare merci di investimento; tutto è subordinato però alla sfera della produzione dato che non si può realizzare del plusvalore, ossia dei profitti, se questo non è stato prima prodotto. Di seguito verranno analizzati separatamente i tre mercati, tenendo però presente questa subordinazione al momento produttivo. Il mercato del lavoro Esso è il luogo in cui si contratta l’assunzione dei lavoratori da parte dei capitalisti, ma è anche il luogo in cui si contratta non una prestazione generica ma una merce particolare: la merce forza-lavoro. Esso è quindi è un mercato particolare in cui il lavoro viene visto come forza-lavoro e come merce. In realtà si potrebbe parlare di un mercato generale delle merci, compresa anche la forza-lavoro. Se essa viene tenuta separata è perché lo stesso Marx riconosce alla merce forza-lavoro un carattere diverso dalle altre merci: è l’unica merce infatti in grado di generare plusvalore. È perciò una merce del tutto particolare. Come funziona il mercato del lavoro nella visione marxiana? La compravendita di questa merce è legata al pagamento di un salario di sussistenza. Da questo punto di vista il salario è ancora in Marx un salario di sussistenza come per Ricardo, come per lo schema classico, però con questa profonda differenza: che il salario di sussistenza in Marx non è condizionato dal movimento demografico della popolazione, non dipende cioè da leggi di natura, ma da un fatto interno al sistema, vale a dire dalla presenza di un esercito industriale di riserva il quale è determinato dal fatto che i capitalisti col loro agire provocano disoccupazione e la concorrenza che si genera tra i lavoratori per trovare lavoro porta i salari ad abbassarsi. Ne consegue che il salario di sussistenza è tale non per fatti di natura, ma per fatti provocati dal capitalista nella sfera della produzione a seguito della introduzione di macchine, di innovazioni tecnologiche che accrescono la produttività. Qui emerge la prima grossa differenza tra lo schema classico e Marx: egli parla di salario di sussistenza ma non legato a leggi naturali, bensì a leggi interne al sistema, all’esistenza di un esercito industriale di riserva. Occorre tener presente innanzitutto che mentre nel mondo classico in realtà non si parlava di disoccupazione perché c’erano o vivi o morti, di non occupato non c’era nessuno, nel mondo di Marx invece di disoccupati ce ne sono. È pertanto uno schema di mercato del lavoro in cui è presente il fenomeno della disoccupazione, provocata dal sistema capitalistico, provocata nella sfera della produzione dal comportamento dei capitalisti. Ma c’è una seconda differenza importante per quanto riguarda il mercato del lavoro e tocca il concetto stesso di salario di sussistenza. Nel pensiero classico il salario di sussistenza è legato a un fatto prevalentemente biologico (corrisponde a ciò che è necessario per vivere), per Marx invece il salario di sussistenza è legato alle condizioni storiche di un dato Paese, di un dato sistema socio-economico. Perciò egli parla di bisogni storicamente determinati e non solo biologicamente determinati. Per di più il salario di sussistenza nella visione di Marx è un minimo, non è la norma. Questa visione sociale cioè di salario minimo di sussistenza, non biologico, ma connaturato alle condizioni storico-sociali del tempo, rappresenta comunque un livello minimo perché la caratteristica del salario è quella di essere determinato dal conflitto fra le parti (lavoratori e capitalisti). Riassumendo in Marx si ha: a) che il salario è condizionato dall’esercito dei disoccupati, è un salario di sussistenza che però non è il minimo biologico ma è legato alle condizioni sociali e storiche del sistema; b) che rappresenta un minimo, cosicché i lavoratori hanno non soltanto tutto il diritto ma tutto il dovere di chiedere incrementi salariali sempre e comunque. Il salario può essere aumentato ed il limite inferiore è rappresentato da quello minimo di sussistenza. E’ quello che accade nella sfera della produzione che condiziona le vicende del mercato del lavoro: i disoccupati non sono un fatto di natura ma un fatto provocato dai capitalisti nel momento della produzione, nella sfera della produzione. Il mercato delle merci Il mercato è il luogo in cui si producono e scambiano merci di sussistenza, merci di consumo e merci di investimento. Per Marx la produzione delle merci non è legata a un elemento puramente tecnico, dato che la tecnica di produzione non è altro che l’espressione di un rapporto sociale di produzione. Nel momento della produzione delle merci non vi è un rapporto tra cose ma un rapporto di persone: i lavoratori vengono utilizzati, la loro forza-lavoro viene utilizzata dai capitalisti nella sfera della produzione al fine di estrarre il plusvalore. Nella produzione delle merci questo aspetto è essenziale dato che non è riconducibile ad un mero fatto «tecnico» essendo il portato di certi rapporti sociali tra le classi. E’ in questo momento che si estrae il plusvalore dalle produzioni delle merci che è poi quello che conta per i capitalisti: ad essi infatti non importa dar lavoro ai disoccupati e neanche far crescere il sistema, bensì estrarre il plusvalore. Nel mercato delle merci la tecnica di produzione non è dunque un aspetto indipendente, come per i classici: la tecnica è la «composizione organica» del capitale, cioè il modo in cui si combinano lavoratori e macchine nel processo di produzione del plusvalore. E poiché il plusvalore deriva solo dal lavoro vivo, dai lavoratori, la tecnica non è indipendente, non è un “fatto tecnico” appunto, ma è un fatto interno ai rapporti sociali tra le classi ed in particolare tra la classe dei lavoratori e la classe dei capitalisti. Le merci prodotte devono trovare uno sbocco: le merci di consumo vengono destinate al consumo dei lavoratori e dei rentiers e le merci d’investimento all’investimento dei capitalisti. Da questo punto di vista sembrerebbe che Marx dica le stesse cose dei classici, ma invece non è così dato che introduce delle osservazioni importanti ed originali. Prima osservazione: è vero che una parte delle merci andrà al consumo dei lavoratori, però è anche vero che esistono dei disoccupati. Nel mondo classico, non esistendo disoccupati, la quota di merci per il consumo necessario ( merci di sussistenza) va solo ai lavoratori, i quali possono acquistarla col salario di sussistenza. In questa diversa concezione, il capitalista mentre produce merci di consumo che sono appunto quelle necessarie alla sussistenza dei lavoratori, genera anche disoccupati. Può succedere allora che si producano merci di consumo che non si vendono perché ci sono i disoccupati e non si vendono non perchè sono diminuiti i bisogni ma perchè non c’è una massa salariale in grado di acquistarle. Nel mondo classico questo era impossibile, nel mondo marxiano è possibile. È questa una contraddizione del capitalista che vuole produrre e vendere le merci e guadagnarci, però nel contempo crea disoccupati che non possono comprare merci. Quindi non è detto che le merci prodotte siano poi vendute come consumo. Seconda osservazione. Anche Marx analizza la rendita, però, nella sua teoria, essa è secondaria rispetto alla posizione che viene fatta assumere dai classici. Mentre nel mondo classico la rendita è importante perché è quella che tende a crescere, che toglie spazio sia al salario dei lavoratori, sia agli investimenti dei capitalisti, per Marx la rendita non è il problema più importante poiché il rapporto fondamentale è quello tra capitalisti e lavoratori, tra salari e profitti. La rendita è quella parte di reddito che potrebbe determinare un contrasto interno tra rentiers e capitalisti, ma non decisivo per le sorti del sistema. Per quanto riguarda la produzione di merci destinate all’ investimento e che dovrebbero essere acquistate dagli stessi capitalisti per allargare la produzione, Marx, a differenza degli economisti classici, osserva che non esiste alcun automatismo che porti i capitalisti ad investire e, perciò, ad acquistare sempre tutti i beni di investimento prodotti. Per i classici ciò accadeva sempre, automaticamente, perché compito del capitalista era infatti quello di fare investimenti, per Marx questo non è affatto detto: può accadere e può non accadere. Keynes su questo punto, dopo molti decenni, dirà che tutto dipende dalle aspettative dei capitalisti circa la possibilità di vendere, di trovare domanda per il prodotto. Keynes parla di aspettative, Marx non parla di aspettative però c’è una certa vicinanza, nel senso che il capitalista non investe automaticamente perché può fare scelte diverse; non ha un comportamento definito ed unico come nel mondo classico. Sono perciò possibili diverse ipotesi di comportamento del capitalista. Ecco alcuni casi come esempi. Un capitalista che produca merci di consumo va sul mercato per venderle e non le vende perché ci sono disoccupati e quindi non c’è domanda effettiva per le sue merci; non vendendole, non realizza il profitto, sebbene abbia estratto il plusvalore che è incorporato nella merce; la merce, non essendo venduta, non consente al capitalista di realizzare il profitto; mancando il profitto, a maggior ragione non investirà. Questo può essere un motivo per cui non investe. Secondo caso. Lo stesso capitalista produce delle merci, le ha vendute e ha realizzato il profitto: può succedere però che preferisca non impegnare questo profitto nell’acquisto di beni di investimento e tenerlo liquido. Emerge a questo proposito l’importanza del mercato della moneta. Il capitalista può preferire di tenere il denaro perché magari aspetta occasioni migliori in un domani per investirlo, oppure perchè, facendo un calcolo di redditività, ritiene di non guadagnarci troppo e rischiare troppo; oppure pensa di operare sul mercato della moneta, sul mercato finanziario, così il profitto invece di essere destinato all’investimento potrebbe essere destinato a speculazioni finanziarie perché ci si guadagna di più; oppure, semplicemente egli può tenere il profitto senza investirlo come atto politico, come mezzo di pressione politica. Per una serie di motivi quindi il capitalista o non ottiene profitti, essendoci una crisi di vendita, oppure se anche li ottiene, non è detto che investa automaticamente. È molto aleatoria perciò questa componente dell’investimento, può attuarsi e può non attuarsi; essa dipende da decisioni prese dai capitalisti. Ed è da queste decisioni che dipende tutto il resto: lo stesso processo di accumulazione e l’assunzione o meno di nuovi lavoratori. Da tutto ciò deriva l’importanza del mercato della moneta: è infatti il luogo in cui c’è una merce particolare, che è la merce moneta, che può essere utilizzata per motivi di speculazione e questi motivi di speculazione entrano direttamente in conflitto con motivi di investimento. Il mercato della moneta e il mercato delle merci sono quindi intrecciati: se si investe sul mercato della moneta o in speculazioni finanziarie, è chiaro che si sottrarranno risorse agli investimenti; come pure se si vuole investire, perché magari si hanno delle belle prospettive di vendere la merce in un domani, ci si può indebitare sul mercato della moneta pagando degli interessi che diventeranno costi di produzione. Il mercato della moneta perciò è tutt’altro che neutrale e indipendente. In questo mercato ci sono operatori particolari: ci sono le banche, c’è lo Stato che offre moneta, ma ci sono soprattutto capitalisti finanziari che speculano tra di loro, che giocano a guadagnare attraverso il rialzo o ribasso dei titoli e questo influenza direttamente il mercato delle merci ed influenza perciò la produzione. Produzione, distribuzione, domanda di merci Al primo posto c’è la sfera della produzione che diventa il centro di tutto: è li infatti che avviene l’estrazione di plusvalore, è lì che attraverso il concetto di ripartizione della giornata lavorativa si capisce come tale plusvalore venga generato, è lì l’origine stessa del profitto, l’origine del conflitto di classe, dei rapporti particolari tra le classi del sistema. Dentro la sfera della produzione è compresa e determinata la sfera della distribuzione: non sono due mondi separati come accadeva per i classici. In Marx produzione e distribuzione sono collegati, poiché tutto si genera nella sfera della produzione. Nel momento in cui nella giornata lavorativa si opera la distinzione tra salario e plusvalore, anche la distribuzione tra salari e profitti è determinata. Per quanto riguarda la domanda, cioè l’uso che si fa delle parti del prodotto sociale, secondo Marx può accadere che certe volte non c’è consumo perché si è ridotto il salario; ci possono anche non essere gli investimenti perché il capitalista non è tenuto a farli. Ed anche in questo senso, quello che accade nella sfera della domanda (cioè se consumare o non consumare, se investire o non investire) dipende anche da quello che è accaduto nella sfera della produzione: se nella sfera della produzione si sono licenziati dei lavoratori a vantaggio delle macchine, calerà la domanda di merci di consumo. La sfera della produzione è perciò quella decisiva: solo a partire da essa si possono interpretare i fenomeni che avvengono nella sfera distributiva e nella domanda di merci. Una osservazione sullo schema classico e marxiano a proposito del dibattito attorno alla questione del salario: se esso debba o meno essere considerato una «variabile indipendente». Per quanto riguarda lo schema classico, non esiste nessuna legge che faccia dipendere il salario da altre variabili dell’economia, dato che dipende solo da fattori naturali; esso non dipende dalla produttività. Il dato che invece emerge dalla visione marxiana, dallo schema marxiano, è che esso è determinato dal conflitto di classe. 3 - IL PENSIERO NEOCLASSICO Occorre anzitutto ricordare che non esiste uno schema neoclassico unico dato che esistono tante teorie neoclassiche così come esistevano tante teorie classiche. Perciò la riduzione di diverse teorie ad un’unica va intesa come una forzatura, per altro utile per fini didattici. Questa scuola nasce alla fine dell’’800 e continua per tutto il ‘900 ed è lo schema tutto sommato ancor oggi dominante negli studi di economia e nelle università. E’ una scuola di pensiero che si è diffusa dappertutto. Mentre il mondo classico è un mondo prevalentemente britannico e gli economisti classici erano inglesi, come Smith, Ricardo, Malthus perché in Inghilterra era nata la rivoluzione industriale, tra i neoclassici ci sono economisti inglesi, ma anche svedesi, austriaci, italiani. Tra questi ultimi va ricordato V. Pareto (1843-1923), che diede un notevole contributo allo sviluppo del pensiero neoclassico. Comunque è soprattutto negli Stati Uniti che si afferma la scuola neoclassica e sono i neoclassici americani, accanto a quelli inglesi, che hanno consolidato il peso politico di questa teoria. Operando una forzatura tra i diversi filoni teorici si cercherà di costruire un modello neoclassico. I tre mercati (del lavoro, delle merci, della moneta), che per i classici erano indipendenti ma che per Marx erano tutti collegati e subordinati alla sfera della produzione, in questa teoria si dividono in:
e
I due mercati importanti sono collegati, ma in questo senso: che il più importante è il mercato del lavoro dato che quello che accade sul mercato del lavoro condiziona il mercato delle merci. Quindi c’è un nesso di causa-effetto. Al primo posto il mercato del lavoro, perché lì accadono dei fenomeni che portano delle conseguenze sul mercato delle merci. Il mercato della moneta non riveste particolare rilievo. Questa teoria si distingue quindi dalle altre in quanto vi sono due mercati decisivi, ma quello che conta di più è il mercato del lavoro cui è subordinato il mercato delle merci. Il mercato del lavoro Partire dal mercato del lavoro, in questo schema, significa partire dal centro del sistema. I neoclassici immaginano un mercato del lavoro libero, a cui liberamente partecipano liberi individui non distinti in lavoratori e capitalisti, ma liberi individui che offrono non una merce ma un servizio. Su questo mercato non si vendono merci, ma si offrono semplicemente prestazioni di lavoro. Da una parte c’è un individuo che offre, dall’altra c’è un individuo che domanda: non c’è un lavoratore contro un capitalista, ma vi sono individui che decidono liberamente se, come, quando e quanto lavorare. Il punto di partenza in questo mercato è che vi sono persone che decidono liberamente se lavorare o non lavorare, e decidere se lavorare o non lavorare dipende da decisioni strettamente soggettive, individuali. Per esempio: un individuo decide di non lavorare se ha i mezzi per vivere, oppure decide di lavorare se trova conveniente impiegarsi e avere in cambio redditi per soddisfare i propri bisogni, naturalmente a condizione che questa soddisfazione dei suoi bisogni sia superiore al sacrificio che ha fatto per lavorare. Il calcolo razionale operato da ognuno di questi individui è quello di mettere a confronto la disutilità del proprio lavoro e la utilità che deriva dal reddito ottenibile. Quindi si danno persone assolutamente libere di decidere se lavorare o non lavorare (non c’è quindi il concetto di sussistenza), persone libere che fanno un calcolo di convenienza: conviene o non conviene lavorare? Dal confronto razionale tra sacrificio e soddisfazione esse decidono se lavorare o non lavorare. Può succedere che, facendo questo confronto, il sacrificio appaia più alto della soddisfazione ricavabile dal reddito, cosicché ci si rifiuti di lavorare. Oppure che, se i salari sono ritenuti bassi, una parte dei lavoratori si ritirino dal mercato spontaneamente. In questa maniera, attraverso questo calcolo soggettivo, quella che diventa la legge-base dei neoclassici è la cosiddetta legge della domanda e dell’offerta nel mercato del lavoro. Certi individui si offrono soltanto se i guadagni che ottengono superano i sacrifici che sostengono, ma se questi guadagni vengono ritenuti insufficienti rispetto ai sacrifici essi non si offrono; non offrendosi, diminuisce il numero dei lavoratori, allora gli imprenditori sono disposti ad aumentare il salario per richiamare i lavoratori: questo aumento del salario fa sì che una parte dei lavoratori rientri sul mercato del lavoro perché questa volta il guadagno supera il sacrificio. Il salario allora diventa un prezzo che può andare su o giù, che non presenta un limite minimo e un limite massimo dato che dipende dalle decisioni individuali. Questo dal lato della offerta di lavoro. Dal lato della domanda di lavoro i neoclassici non pongono una «classe» ma l’insieme di chi vuole assumere lavoratori. Gli individui nel mondo neoclassico infatti si dividono in individui lavoratori che si offrono e individui produttori che domandano; questa distinzione non è una distinzione di classe perché chiunque può essere individuo-lavoratore o individuo-produttore. La decisione di mettersi a lavorare alle dipendenze di un altro oppure in proprio è decisione individuale e libera. Esiste proprio in questa teoria la visione della libertà dell’individuo di agire in proprio o di agire come dipendente, quindi ognuno può essere un individuo-lavoratore ma anche un individuo-imprenditore, un individuo-produttore, perché c’è sempre la possibilità per tutti di partecipare al processo di produzione delle merci e dei servizi del sistema economico. C’è questa libertà di individui uguali che possono svolgere più funzioni. In questa visione del mercato del lavoro sono gli individui a decidere quante sono le persone occupate, perché sono loro che decidono se partecipare al mercato o uscirne. Sul mercato del lavoro si decide quindi il livello dell’occupazione indipendentemente dal resto ed è chiaro che con quell’occupazione si potrà avere una certa quantità di produzione sul mercato delle merci. Sulla base perciò di scelte individuali, si decide quanta gente lavora, una volta deciso quanta gente lavora si sa quant’è il prodotto ottenuto, come conseguenza della scelta precedente. Esiste quindi un mercato che condiziona il mercato delle merci, un mercato in cui però non c’è disoccupazione, ossia impossibilità di lavorare per chi avrebbe volontà di farlo e c’è sempre teoricamente piena occupazione. Questa è la prima conseguenza di questa visione. Seconda conseguenza sul mercato del lavoro: il salario è una variabile dipendente o indipendente? Per i neoclassici esiste una legge che pone una specie di disciplina alle scelte e preferenze individuali: è la legge della produttività del lavoro secondo cui nessuno (decida di lavorare o non lavorare, di entrare o non entrare) può chiedere di ottenere una ricompensa superiore al contributo che ha dato alla produzione. E’ la famosa legge della «produttività marginale» che condiziona la formazione del salario: il salario è una variabile dipendente poichè dipende dalla produttività del lavoro. Non può essere nè al di sopra della produttività del lavoro perché altrimenti questo significa turbamenti, squilibri nel sistema, né può essere inferiore alla produttività del lavoro altrimenti la gente si ritirerebbe spontaneamente dal lavoro perché non gli converrebbe. Per i neoclassici la legge della produttività è una legge generale, non è un fatto legato soltanto al lavoro. Nel mondo neoclassico abbiamo detto che esistono tanti individui, non esistono le classi e nel momento in cui esistono tanti individui si postula una separazione tra l’individuo e i fattori della produzione. Quali sono questi fattori? Innanzitutto il lavoro; il capitale, cioè i mezzi di produzione; la terra e le altre risorse. Capitale e mezzi di produzione sono risorse accessibili a chiunque. Nella concezione neoclassica anche un semplice lavoratore può, risparmiando, diventare proprietario di quote di capitale. Queste risorse non fanno capo a determinati individui, altrimenti avremmo le classi, ma sono il risultato di comportamenti individuali, dipendendo dalla capacità di sacrificio di ciascuno; ognuno può essere lavoratore, capitalista e proprietario terriero solo che sia in grado di compiere sacrifici. In cambio della offerta dei fattori di produzione vengono pagati salario per il lavoro, il profitto per il risparmio e la rendita per le risorse naturali. Ma sulla base di quali criteri economici vengono pagate queste risorse? Per ognuno dei fattori è valida la legge della «produttività marginale»: la legge della produttività del lavoro determina il salario, così come la legge della produttività della terra condiziona la rendita e la legge della produttività del capitale condiziona i profitti. La legge della «produttività marginale del lavoro» sostiene che il lavoro da solo non ha nessun significato: il lavoro va posto accanto alle altre risorse (capitale e terra), va applicato a una data quantità di altre risorse perché la produzione proviene dalla combinazione dei fattori ed il lavoro, senza terra, risorse e capitale non potrebbe produrre alcunché. Tale lavoro è soggetto alla «legge della produttività marginale decrescente»: essa dice che se si applica più lavoro a una data quantità di altre risorse e i1 lavoro aumenta mentre restano uguali le altre risorse, il prodotto che si ottiene aumenta ma in modo meno che proporzionale. Ad esempio, si supponga che un agricoltore abbia a disposizione della terra di 10 ettari e un trattore. Restando uguali terra e trattore, se egli vuole aumentare il prodotto dovrà accrescere il proprio lavoro o assumere altri lavoratori. Se lavora un’ora al giorno, avrà meno prodotto che se lavorerà invece due, sei, otto ore al giorno. Fino ad un certo punto l’applicazione di più ore di lavoro alla stessa terra, utilizzando sempre l’unico trattore, apporterà incrementi di produzione via via maggiori e più che proporzionali. Da un certo punto in poi l’aumento di lavoro porterà sì ancora ad incrementi di produzione ma meno che proporzionali all’incremento del lavoro applicato. Se l’agricoltore, per riprendere l’esempio, raddoppia il suo lavoro del 100%, portandolo da 8 ore a 16 ore, otterrà sì un aumento di produzione, ma non del 100%, bensì dell’80%, del 40% eccetera. Questa minore produzione marginale (per cui, ad esempio, raddoppiando le ore di lavoro si ottengono incrementi produttivi prima dell’80%, poi del 60%, poi del 40% ecc.) è, secondo i neoclassici, determinata dal fatto che, da un certo punto in poi, il fattore lavoro, restando uguali gli altri fattori, si combina sempre peggio e rende perciò via via di meno. L’idea dei neoclassici è perciò che la produzione aumenta, ma in modo meno che proporzionale all’aumento dei fattori e questo condiziona tutte le retribuzioni. Se si vuole aumentare l’occupazione, la produttività del lavoro diminuirà a parità delle altre condizioni e diminuendo la produttività del fattore lavoro diminuirà il salario. Ogni fattore produttivo viene redistribuito sulla base del suo contributo alla produzione. Il salario dell’ultima ora di lavoro impiegata sarà uguale alla produttività dell’ultima ora di lavoro impiegata. Da ciò si ricava una visione del mercato del lavoro secondo cui esso sarebbe un luogo di persone libere e indipendenti che decidono liberamente, soggette tutte al vincolo rispetto alla legge della produttività, per cui il salario deve essere pari al contributo che viene dato dagli individui alla produzione. Il mercato delle merci Le merci vengono prodotte in luoghi tecnici che si chiamano imprese. Per i neoclassici non compaiono più il «capitalista» e il «lavoratore», bensì portatori potenziali di diversi fattori produttivi. Funzione fondamentale di chi produce, dell’imprenditore, è quella di scegliere la tecnica migliore di combinazione dei fattori. Per i neoclassici la scelta della tecnica migliore è una caratteristica delle imprese. Nel mondo classico non c’era problema, poiché si presupponeva che la tecnica migliore fosse già data; per il mondo marxiano la tecnica in sé non ha senso, poiché il capitalista sceglie la tecnica che gli è più conveniente in base ai rapporti sociali. I neoclassici pensano invece che vi siano tante possibili scelte e che uno dei compiti dell’imprenditore e quello di scegliere la combinazione tecnica migliore. Una volta scelta la tecnica, si producono delle merci; merci che sono merci di consumo e merci di investimento. Che sbocco hanno queste merci? Trattandosi di individui liberi, essi non sono obbligati, come nel mondo classico, a sopravvivere, a chiedere un salario di sussistenza, ma in questo mondo neoclassico, una volta prodotte le merci, saranno gli individui stessi a decidere se, quando, quante merci comprare al fine di soddisfare i propri bisogni. Quindi non c’è un «consumo di sussistenza» ed ognuno consuma le merci in base alle scelte che fa liberamente relativamente ai propri bisogni. Questo è il meccanismo di «libertà di scelta»: un individuo può decidere di consumare tanto o di consumare poco, consumare una certa merce o un’altra merce ed anzi, sono le sue scelte che condizionano poi la sfera della produzione e così se sceglie certe merci si produrranno quelle merci, se ne sceglie delle altre se ne produrranno delle altre. Viene qui enunciato il principio della «sovranità del consumo», perché il consumatore è sovrano di decidere se, come e che cosa consumare, oppure non consumare, perché è libero di scegliere sulla base dei propri bisogni. I neoclassici negano la possibilità di crisi causate da merci non vendute. Ciò che non è consumato, cioè il risparmio, finisce in investimento. Il non consumo non è una scelta negativa, ma scelta di investimento. I neoclassici postulano l’esistenza di meccanismi automatici per cui se la gente consuma troppo e gli individui produttori hanno bisogno invece di beni di investimento che sono pochi, pur di avere beni di investimento, cioè pur di stimolare il risparmio, gli imprenditori saranno disposti a pagare un premio a chi risparmia: questo premio si chiama «tasso di interesse». Il tasso di interesse remunera il sacrificio di non consumare nell’immediato: quanto più è elevato, tanto più stimolerà i risparmi. Se il tasso di interesse cresce, molti sono portati a non consumare, a risparmiare, offrendo i propri risparmi all’imprenditore, il quale allora può avere le risorse per produrre. Ecco che il meccanismo è proprio quello secondo cui il saggio di interesse decide quanto consumare e quanto risparmiare e quello che viene risparmiato viene automaticamente investito perché il meccanismo è appunto tale che con il premio che si dà a chi risparmia si aumenta o si diminuisce quella quantità di risparmio che viene poi investita. Quindi in questo mercato delle merci non si ha, come nel mondo classico, che i lavoratori consumano e i capitalisti investono, non si ha come nel mondo marxista che i consumatori possono anche non consumare perché sono disoccupati e i capitalisti possono non investire per loro decisione. Qui si ha un’altra prospettiva: non esistono né lavoratori nè capitalisti, esistono persone che ottengono dei redditi — redditi da lavoro, redditi da capitale, redditi da terra — che decidono di consumare o non consumare liberamente, che possono risparmiare oppure consumare, naturalmente il tutto essendo regolato dal meccanismo di mercato. Il meccanismo automatico di equilibrio in questo mercato delle merci è il saggio di interesse: tanto meno si risparmia, tanto più si consuma di fronte a una certa richiesta di capitale, tanto più sarà alto il tasso di interesse. Il mercato della moneta Nel mondo neoclassico il mercato della moneta ha poco rilievo, essendo la moneta solo un mezzo per gli scambi. Quello che conta sono gli altri due mercati, in un rapporto di subordinazione: sul mercato del lavoro si decide la quantità di prodotto; la quantità di prodotto sarà consumata o risparmiata attraverso il meccanismo del tasso di interesse; tutto automaticamente tende all’equilibrio. Produzione, distribuzione e domanda di merci Produzione Per i neoclassici la sfera della produzione non è una sfera indipendente dalle scelte delle persone, come per i classici. Le tecniche della produzione vanno scelte, tant’è che l’economia diventa la scienza delle scelte, anche relative alle diverse tecniche di produzione. I tre fattori da combinare (lavoro, terra e capitale) nel processo di produzione rispettano la legge della produttività marginale decrescente, secondo cui, a parità di certe risorse, all’aumentare di una risorsa il prodotto aumenta in modo meno che proporzionale. È questa una “legge tecnica” della produzione; dati certi fattori, all’aumentare di una risorsa o fattore variabile, il prodotto aumenta in modo meno che proporzionale. Questa legge fondamentale, questa legge tecnica condiziona la sfera della distribuzione: infatti ogni fattore produttivo sarà pagato in base al contributo che questi fattori hanno dato. Il contributo del lavoro va separato dal contributo della terra e dal contributo del capitale. Il profitto sarà pagato in proporzione al contributo del capitale e la rendita in proporzione al contributo della terra. Salario, rendita e profitto vengono perciò considerati «ricompense» mentre per le scuole precedentemente esaminate il salario o è un fatto di sussistenza e il profitto un residuo (classici), o salario e profitto sono determinati dalla lotta di classe (Marx) per cui non c’è nessuna legge che decide se il salario debba essere più alto o più basso, ciò che conta è il conflitto. Per i neoclassici invece salari, profitti e rendite sono prezzi che retribuiscono i sacrifici dell’individuo lavoratore, dell’individuo-risparmiatore, dell’individuo-proprietario: sono ricompense legate all’esistenza della legge della produttività. Vediamo come il salario viene determinato da questa legge secondo i neoclassici. Si supponga che vi sia da coltivare un campo di 10 ettari con una data quantità di attrezzi. Assumendo 1 lavoratore si potranno ottenere, ad esempio, 10 quintali di grano. Assumendone 2 si otterranno 22 quintali; con 3 lavoratori se ne otterranno 31; con 4 lavoratori infine 38 quintali. Riassumendo:
La variazione di quantità prodotta per ogni lavoratore aggiuntivo è indicata nella tabella per cui si ha: 2 lavoratori — produzione marginale determinata dall’ultimo lavoratore: + 12 3 lavoratori — produzione marginale determinata dall’ultimo lavoratore: + 9 4 lavoratori — produzione marginale determinata dall’ultimo lavoratore: + 7 Quale salario sarà pagato, o dovrebbe essere pagato, al quarto lavoratore? Se si suppongono uguali a zero i costi connessi ai mezzi di produzione, il prodotto viene ripartito tra salari e profitti. Se, supponiamo che il salario dell’ultimo operaio (il 4°) fosse uguale a 9 quintali di grano, l’imprenditore che lo ha assunto non avrebbe tratto nessun vantaggio, anzi, ne ricaverebbe una perdita di 2 quintali (differenza tra i 38 q. complessivi ottenuti col 4 lavoratore ed i 31 ottenuti con 3 lavoratori. In altre parole il 4 lavoratore aggiungerebbe ai 3 precenti una produzione di solo 7 q. a fronte dei 9 ricevuti in salario). Il quarto lavoratore sarà assunto ma ad un salario che al massimo sarà di 7 quintali: solo a questo livello ciò che rende il lavoratore per la produzione sarà uguale a quanto egli viene a costare all’imprenditore. Se il suo salario richiesto fosse stato di 9 o anche 8 quintali, l’imprenditore non trarrebbe alcun vantaggio dalla sua assunzione. Il lavoratore deve essere pagato in base al contributo offerto. Se il quarto lavoratore ha aggiunto 7 quintali alla produzione totale non può essere pagato 8, perché sarebbe antieconomico e neppure può essere pagato meno perché in questo caso sarebbe richiesto dalle altre imprese che farebbero aumentare il suo salario: gli sarà dato un salario corrispondente a 7 quintali. Quindi l’ultimo lavoratore è pagato in base al contributo marginale è gli altri sono pagati in base al salario di 7 quintali, cioè in base al contributo dell’u1timo lavoratore. Il primo ha dato un contributo di 10 q., il secondo 12 q., il terzo di 9 q., il quarto di 7 q. ma tutti saranno pagati con un salario di 7 q. Tutto ciò è determinato da una legge tecnica, per cui il salario risulta una variabile dipendente. Ecco che allora il salario dipende dalla produttività del lavoro per l’ultimo lavoratore, che regola il salario di tutti: 7 q. diventa il salario del quarto, ma anche quello degli altri. Poichè in totale la produzione è di 38 quintali, allora avremo la seguente ripartizione: 4 x 7 = 28 q in salari ed i restanti 10 q andrà all’imprenditore come profitto. Questa è la legge della produttività che regola la formazione del salario come variabile «dipendente». Lo stesso discorso si potrebbe fare per tutti gli altri fattori. Rispetto al salario, esiste quindi una relazione tra salario pagato e occupazione, ed il salario dev’essere corrispondente alla produttività dell’ultimo lavoratore che si identifica col contributo del lavoratore alla produzione. Questa legge. implica che se si vuole più salario, si licenzino dei lavoratori, mentre se si vuole aumentare l’occupazione bisogna diminuire i salari perché se si aumenta l’occupazione il contributo che via via si dà è sempre più minore. Dalla legge della produttività marginale del lavoro emerge come la produzione determina la distribuzione del reddito. Riguardo alla domanda, i neoclassici sostengono che è il tasso di interesse a regolare il mercato delle merci, stabilendo la quota che va al consumo e la quota che va al risparmio. 4 - IL PENSIERO DI KEYNES La teoria keynesiana verrà ora considerata seguendo i tre mercati così come per le precedenti, salvo che in questo caso verrà seguito un ordine diverso, e cioè si partirà dal mercato della moneta, poi si affronterà il mercato delle merci e infine il mercato del lavoro. Quest’ordine è tale da far emergere i rapporti causa-effetto che secondo Keynes esistono: uno dei mercati più importanti è il mercato della moneta e ciò che vi accade influenza quello che accade sul mercato delle merci, mentre quello che accade sul mercato della moneta e delle merci insieme influenza quello che accade sul mercato del lavoro, il quale resta l’ultima parte del sistema dove si scaricano tutti gli effetti. Il mercato della moneta L’analisi keynesiana della moneta è assai innovativa. Occorre innanzi tutto ricordare che ai tempi di Keynes si pensava che la moneta fosse uno strumento neutrale nell’economia, che cioè non influenzasse le vicende dell’economia reale. Si ragionava come se la moneta servisse soltanto ad agevolare tutto quello che accade negli scambi: è infatti con la moneta che si compra, si vende, si pagano i salari, si spendono i salari ed essa pertanto non rivestiva grande importanza nelle teorie economiche. Questa era una posizione dei neoclassici e una posizione anche, pur con qualche cautela, dei classici per cui la moneta era indifferente al sistema, tant’è che l’avevano piuttosto trascurata. Secondo Keynes invece quello che accade sul mercato della moneta non è affatto neutrale rispetto a quello che accade nel sistema economico, anzi quello che vi accade influenza il sistema a tal punto da essere una delle fonti potenziali della crisi. Keynes contraddice quindi lo schema neoclassico e quello classico e per certi punti di vista si avvicina a quello che aveva detto Marx: per Marx infatti la moneta è qualcosa di importante, che ha influenza sul sistema dell’economia reale, è qualcosa che determina anche le vicende reali e sociali, e determina anche le crisi. Per Marx infatti la moneta o il danaro è un’espressione del capitale, è una espressione della possibilità del capitalista di guadagnare, di fare profitti, di usare il danaro come capitale per ottenere plusvalore, di usare il danaro per investire, oppure per non investire, influenzando in tal modo quello che accade nel sistema. Keynes riprende questa linea. Ma si badi, quello che per noi oggi sembra normale, che cioè le vicende della moneta influenzino le vicende dell’economia reale e sociale, non lo era affatto fino agli anni Trenta. L’offerta di moneta nella teoria keynesiana Sul mercato monetario ci sono due attori fondamentali: da un lato lo Stato che sul mercato della moneta emette moneta, offre moneta. Esso viene considerato come qualcosa di esterno, di autonomo, esogeno: decide di emettere moneta seguendo le decisioni delle proprie autorità. La domanda di moneta per transazione Da una parte quindi c’è lo Stato, l’istituzione che stampa moneta legale, dall’altra sul mercato della moneta agiscono due figure di operatori: una figura rappresentata da coloro che chiedono moneta, che hanno bisogno di avere moneta per effettuare scambi, transazioni. Chi, ad esempio, deve ricevere il salario, chiede moneta perché gli acquisti si fanno con moneta e tutto il sistema è basato su di essa. Il mercato della moneta di Keynes
s La decisione di 1 di incontrarsi con quelle di 2 e 3 determinano il saggio di interesse il quale influenza gli investimenti e, perciò, l’economia reale. Domanda di moneta per speculazione Un altro tipo di intervento sul mercato della moneta, cui corrisponde un’altra figura di operatore, è formata dagli speculatori[2] i quali intervengono professionalmente sul mercato della moneta. Gli speculatori chiedono moneta e giocano sulla moneta in base a tutt’altri obiettivi rispetto a quelli della pura e semplice transazione. Essi infatti chiedono moneta, tengono moneta, la usano sul mercato finanziario giocando sui titoli, nella Borsa, nelle obbligazioni. Giocando sul mercato finanziario con la moneta — quindi tenendo più moneta o spendendo moneta a seconda delle circostanze — essi influenzano una grandezza fondamentale dell’economia: il tasso di interesse. Il loro comportamento concorre quindi a stabilire il livello del tasso di interesse. Ora, poiché il tasso di interesse, stabilito da una speciale categoria di capitalisti che giocano tra di loro sul mercato finanziario, rappresenta il costo del denaro preso a prestito (per esempio da un imprenditore per finanziare investimenti), ne consegue che esso finisce per influenzare le decisioni di un’altra categoria di capitalisti, che è quella di coloro che devono prendere denaro a prestito per fare investimenti. Ecco che allora attraverso questo meccanismo il tasso di interesse, che viene stabilito per manovre speculative dagli speculatori, influenza — date certe condizioni — gli investimenti, cioè influenza quanto accade sul mercato delle merci. Ne deriva che il mercato della moneta non è affatto neutrale per Keynes, ma influenza, oltre ad altri fattori, una grandezza decisiva, quale quella degli investimenti. Il mercato delle merci Nel mercato delle merci esistono due figure di operatore: da un lato le imprese e dall’altro le famiglie. Le famiglie ottengono dei redditi, che possono essere redditi da lavoro, redditi da capitale, redditi da rendite fondiarie. La famiglia, una volta ottenuto questo reddito, deve decidere quanto consumare e quanto risparmiare: quindi le decisioni delle famiglie sono consumi o risparmi. Dall’altro lato ci sono gli imprenditori. Essi svolgono attività di produzione e per svolgerla devono decidere gli investimenti. Sono questi i due attori fondamentali. Dalle decisioni di questi due attori — quanto uno consuma, quanto uno investe — dipende quello che accade nel sistema nel mercato delle merci: dipende cioè la possibilità che il sistema sia in equilibrio (come diciamo noi) oppure che il sistema possa anche avere cicli, fluttuazioni, sbalzi, crisi. È importante allora vedere che cosa influenza le decisioni dell’operatore “famiglia” e dell’operatore “impresa”. Le famiglie Le famiglie devono decidere quanto consumare e quanto risparmiare. Ebbene, Keynes dice una cosa che oggi sembra banale ma che non lo è affatto se paragonata alle condizioni prevalenti negli anni Trenta. Egli afferma che le famiglie decidono quanto consumare e quanto risparmiare a seconda dell’altezza del reddito che hanno a disposizione. Normalmente tanto più basso è il reddito tanto più basso è il risparmio, tanto più alto è il reddito e tanto più alto il risparmio[3]. Quindi le famiglie consumano o risparmiano in base al reddito, in funzione del loro reddito. Tanto più basso è il reddito delle famiglie, tanto più loro consumeranno, tanto meno risparmieranno. Tanto più alto è il reddito delle famiglie, tanto più i consumi saranno in proporzione più bassi e i risparmi più alti. Ne deriva una prima conclusione importante: che al crescere del reddito i consumi crescono meno che proporzionalmente. Se è vero infatti che tanto più basso è il reddito tanto meno è il risparmio, è chiaro che crescendo il reddito tanto più in proporzione si risparmierà rispetto al consumo. Quindi con il progredire del reddito i consumi aumentano però meno che proporzionalmente rispetto alla crescita del reddito. Questo secondo Keynes è il frutto di una legge psicologica, di una caratteristica del comportamento delle famiglie. Le imprese Le imprese devono decidere se e quanto investire, ecco una decisione che compete solo ad esse[4]. Se il tasso di interesse è alto gli imprenditori investiranno di meno, se il tasso di interesse è basso gli imprenditori investiranno di più. Però questo meccanismo non è affatto automatico: non è detto che tutte le volte in cui il tasso di interesse è basso gli imprenditori si daranno tutti ad investire. Se fosse così automatico allora il sistema non avrebbe problemi: non si avrebbe disoccupazione, non avrebbero crisi. In tale situazione lo Stato potrebbe fare delle manovre monetarie contro gli speculatori per far abbassare il tasso di interesse e favorire così gli imprenditori che investirebbero. Poichè investire significa assumere, l’intervento dello Stato consentirebbe di raggiungere facilmente la condizione di piena occupazione. Per Keynes questo automatismo non sussiste perché per gli imprenditori quello che conta non è tanto il costo del danaro per fare investimenti, quanto i guadagni che avranno o che pensano di avere dall’investimento. Investire significa aumentare la produzione, ma per aumentare la produzione bisogna essere in grado di venderla. Se le imprese hanno prospettive di vendere la futura produzione e guadagnarci, è chiaro che tenderanno ad attuare gli investimenti, ma se le loro aspettative sono negative, anche se il tasso di interesse, cioè il costo del danaro, è molto basso, esse non investiranno. Le aspettative Keynes aggiunge quindi al tasso di interesse (che pure è importante) le aspettative. Gli investimenti dipendono dalle aspettative che hanno gli imprenditori circa la possibilità di vendere le loro merci e trarne profitti. Se le aspettative sono positive ecco che allora scatta il meccanismo del tasso di interesse, ma se le aspettative sono negative, per qualsiasi tasso di interesse basso, tenderanno a non esserci nuovi investimenti[5]. Per riassumere: Mercato delle merci Soggetti
Grafico della domanda e del reddito Le cose già dette verranno ora rappresentate mediante un grafico. Sul lato orizzontale, detto asse delle ordinate, verrà riportato il reddito (Y), cioè la produzione nazionale o reddito nazionale. Quindi ogni punto (per es. Y1 o Y2) indica ad esempio reddito 100 (Y1), reddito 120 (Y2), il quale è più alto andando verso destra.
Il reddito è un insieme di merci e servizi che vengono prodotti nel sistema. Che destinazione hanno queste merci prodotte uguali a Y? Possono avere come destinazione il consumo finale, oppure il consumo produttivo per gli investimenti dei capitalisti. Allora se si prende per esempio un reddito Y 1 (nell’esempio è uguale a 100 lire): questo reddito viene distribuito alle famiglie che avranno un reddito di 100 lire. Se si suppone che le famiglie ne consumino 80, ne risparmieranno 20, perché questo reddito consente di avere anche un risparmio. Sul grafico, se tutto il reddito di 100 lire fosse consumato si avrebbe un consumo = 100 lire nel punto P (È da notare che la linea bisettrice è costruita in modo da rendere eguali i segmenti sulla linea delle ordinate, quella delle Y, e su quella delle ascisse della D, C, I ed S). Si supponga invece che il consumo sia a diverse altezze (linea C) e che quindi la parte del reddito OQ sia consumata e la parte QP risparmiata. La legge keynesiana del consumo è quella che è stata indicata con la linea C: all’aumentare del reddito il consumo aumenta ma meno che proporzionalmente rispetto al reddito Y. In questa situazione, al reddito Y1 il consumo sarà = OQ mentre la parte del reddito non consumata e risparmiata sarà = QP. Questa situazione è determinata dal fatto che le famiglie a quel reddito Y1 (100 €) decideranno di consumare OQ (80 €) e di risparmiare QP (20 €). Vediamo cosa succede sul mercato delle merci in tale situazione: si è prodotto un reddito Y1; si è consumato meno di questo reddito prodotto: restano perciò delle merci invendute, cosicché l’anno successivo i capitalisti ridurranno la produzione perché sono rimaste delle merci invendute. Quindi se non ci sono investimenti, se si produce il reddito Y1 e se con questo reddito abbiamo solo consumo, l’anno successivo si produrrà di meno, si ridurrà la produzione, si ridurrà il reddito, scendendo al punto Y (punto nel quale il reddito Y* = 80 € sarà uguale al consumo OR = 80 €). Ricapitolando. Il reddito Y1 = 100 €: di questi 100 €, le famiglie decidono liberamente di consumarne 80 e di risparmiarne 20. Se non ci sono investimenti da parte dei capitalisti succede che le imprese hanno prodotto per 100, ma soltanto 80 viene loro domandato per essere consumato dalle famiglie, mentre il restante 20 non viene domandato perché le famiglie hanno deciso di non consumare ma di risparmiare. In assenza di investimenti cosa succede perciò? Succede che il resto delle merci saranno invendute perché i capitalisti non comprano merci a scopo di investimenti; l’anno successivo essi perciò produrranno di meno e il reddito — che dapprima era Y1 — scenderà a livello Y*, cioè scenderà al livello in cui tutto il reddito viene consumato, dove il risparmio sarà uguale a O e il nuovo reddito Y* uguale ai consumi. Perché non accada questo processo, perché non si riduca il reddito da Y1 a Y*, occorre che ci siano degli investimenti, che cioè la parte di produzione che non è stata venduta per consumi venga venduta per investimenti (o per altro tipo di domanda). Se ci sono investimenti per una quota, poniamo, uguale a 20 €, tutta la produzione sarà venduta ed al livello di Y 1 = 100 € più alto di Y*. Ci sarà perciò più alta domanda, reddito e occupazioni maggiori. Facciamo un altro esempio per vedere un altro caso. Supponiamo che nell’economia si sia prodotto un reddito uguale a Y2 = 150 €, maggiore di Y1. A questo reddito le famiglie consumeranno la parte OB (sulla linea C). I consumi sono cresciuti (da OQ a OB), ma assai di più sono cresciuti i risparmi (da PQ a AB). Quindi più cresce il reddito, più aumentano i risparmi. Al reddito Y2, rispetto al reddito Y1, il reddito è aumentato, i consumi sono aumentati ma meno del 50%. Si sono allargati i risparmi e allora si sarà allargata la parte di produzione rimasta invenduta. Se le imprese continuano ad investire sempre la stessa quantità che si è aggiunta ai consumi = QP , si noterà che in tale situazione, con un reddito Y2, la parte OB va in consumi, la parte BC (= PQ) va in investimenti, ed allora resta la parte invenduta = AC. Quindi anche se c’è consumo, anche se c’è investimento, può succedere che ci siano merci invendute. Perché questo? Perché magari i capitalisti hanno deciso di investire la quota BC = PQ, di non investire di più ne di meno. Si è detto che queste decisioni le prendono gli imprenditori i quali non investono perché c’è abbondanza di risparmio, né solo perché il tasso di interesse è basso, né tanto meno per dar lavoro ai lavoratori. Essi investono in base a decisioni indipendenti che riguardano i loro interessi, veri o presunti. Nella situazione ora descritta che cosa succederà? Essendoci un eccesso di merci invendute = AC, l’anno successivo gli stessi capitalisti produrranno di meno, si contrarrà la produzione, si contrarrà il reddito, si ridurrà l’impiego dei lavoratori e di fattori produttivi fino al punto in cui tutto il reddito sia o consumato o investito e non vi sia più una quantità di merci invenduta. Perché il sistema sia in equilibrio occorre questa condizione: che i risparmi siano uguali agli investimenti. Se i risparmi sono superiori agli investimenti significa che c’è una parte di merci prodotte e non vendute: l’anno successivo si ridurrà il reddito. Si capisce che il discorso su reddito, consumi e investimenti ha aperto il discorso su fluttuazioni, cicli, crisi. Siccome non c’è niente di automatico, una volta che si conosce la propensione al consumo da parte delle famiglie, tutto dipende dagli imprenditori: se loro investono per un ammontare = alla quota AB, ad esempio, raggiungendo il punto in cui non c’è risparmio, il sistema sarà in equilibrio ad un alto livello di reddito; se invece gli investimenti sono insufficienti a coprire tutta la produzione, il sistema farà sì che la produzione del reddito si autoriduca. È previsto perciò un elemento di crisi: questo è un punto importante della teoria keynesiana. Se infatti accade che vi sia un’insufficienza della domanda effettiva (consumi delle famiglie + investimenti delle imprese) allora si produce di meno, producendo di meno l’anno successivo si licenzierà, determinando la crisi sul mercato del lavoro. È questa una spiegazione della crisi in cui tutto dipende da decisioni autonome indipendenti dei capitalisti per quanto riguarda gli investimenti. Si noti che secondo Keynes gli elementi di crisi derivano dal fatto che le famiglie hanno aumentato il reddito e risparmiano di più. In questo senso Keynes fa capire che il risparmio è un fatto negativo. A livello personale, del singolo, ognuno di noi probabilmente si deve attenere al concetto del “buon risparmio”, però a livello di sistema economico le decisioni di non consumare, cioè di risparmiare, sono negative. Tanto più le famiglie risparmiano tanto meno merci acquistano, tanto più determinano condizioni di crisi dato che risparmio di merci significa sottrazione di domanda di merci, minor consumo e gli stessi capitalisti saranno indotti a fare ancora meno investimenti. In quest’ottica il risparmio è negativo. Questa è la prima conclusione. Se questo è il lato negativo dell’analisi di Keynes rispetto al capitalismo, c’è il lato positivo “riformistico”: il fatto che si può avere una indicazione per impedire questa possibilità di crisi. Poiché è molto raro che tutte le merci siano vendute e che con ciò, in conclusione, gli investimenti eguaglino i risparmi (I=S), normalmente accade che si sia molto lontani dall’equilibrio normale ed automatico del sistema. Keynes individua allora uno strumento per risolvere il problema. Se sono state prodotte merci per un totale = Y2, queste sono state prodotte perché nel passato sono state prese delle decisioni. La quantità di merci OB è stata consumata, la parte BC investita e ci sono merci in più invendute = AC, reddito in più che viene distribuito e che non viene usato nell’acquisto di merci. Questo pone le condizioni della crisi. Come risolvere il problema? Ecco l’intervento di Keynes: la spesa pubblica. La spesa pubblica Lo Stato interviene distribuendo soldi, accrescendo così in modi diversi la domanda di merci. Questa domanda di merci stimola i consumi, oppure le imprese a investire, a produrre di più. Con una spesa pubblica, aggiungendo la differenza (poniamo = AC) si crea domanda aggiuntiva: gli imprenditori di fronte a una domanda maggiore hanno prospettive di vendere le merci, fanno investimenti: si mette così in moto addirittura un meccanismo moltiplicativo. Una spesa pubblica non significa soltanto far comprare le merci invendute, ma significa creare aspettative favorevoli per altri investimenti, quindi stimolare per il futuro la crescita del reddito. Quindi l’intervento dello Stato è quello che garantisce di non tornare indietro, di non avere crisi, ma addirittura di andare avanti fino al punto in cui per esempio si investe tanto da impiegare tutti i disoccupati, raggiungendo una posizione di pieno impiego. Punto essenziale per Keynes è dunque la spesa pubblica, cioè una componente esterna di domanda decisa dallo Stato, dal governo, che impedisce il processo di ritorno indietro del reddito o squilibri continui nel sistema. Quindi lo Stato avrebbe la funzione di stabilizzare il sistema, sostenendo la domanda effettiva. Questa è l’idea keynesiana che ha retto le politiche keynesiane nel secondo dopoguerra. Questo meccanismo è tutto l’opposto di quello neoclassico, che non ammetteva invece le crisi di carenza di domanda e non ammetteva neanche l’intervento dello Stato; per tali teorie infatti l’intervento dello Stato era addirittura perturbatore, era inutile, perché il sistema era in grado di autoregolarsi da solo. Il mercato del lavoro Il mercato del lavoro, nella visione keynesiana, è il luogo in cui si hanno tutti gli effetti di quello che è stato illustrato in precedenza. Si noti che nella teoria neoclassica il mercato del lavoro era al primo posto e non all’ultimo e lo era in quanto gli individui erano in grado e liberi di decidere se lavorare e quanto lavorare. E’ chiaro che una volta che decidevano se lavorare e quanto lavorare, una volta che pertanto veniva deciso il livello di occupazione (che necessariamente era di piena occupazione, date avevano deciso loro in quanti lavorare), data quindi quell’occupazione, si calcolava quant’era la produzione ricavabile da quell’occupazione. Quindi la produzione, il reddito era il risultato dell’occupazione decisa autonomamente dai lavoratori i quali decidevano se era conveniente per loro lavorare o non lavorare a quel certo salario. Nell’ottica di Keynes chiaramente è tutto il contrario; nessuno è così libero da valutare se e quanto lavorare e come lavorare, in modo che il reddito nazionale o la produzione che si ottiene sia il risultato delle nostre scelte libere di lavoratori. Secondo Keynes sul mercato del lavoro si scaricano le conseguenze di decisioni prese sul mercato delle merci e sul mercato della moneta. Perché? Perché le famiglie consumano, le imprese investono, decidono loro se e quanto investire, e a seconda di queste decisioni si saprà qual è il reddito ed a seconda della produzione si avrà il livello di occupazione. L’occupazione è quindi il risultato di tutti questi elementi che stanno a monte. In ogni caso tutto ciò che vi accade (decisioni di consumo, decisioni di investimento), si rifletterà sul livello dell’occupazione. Quindi il livello di occupazione è il risultato e non il punto di partenza. Riguardo al mercato del lavoro, Keynes dice che non è affatto vero che i lavoratori sono liberi di decidere se lavorare o non lavorare o quanto lavorare; non c’è questa libertà, non c’è questo calcolo razionale, per cui si può fare un discorso di convenienza. Questo non è vero sostanzialmente, anche se può risultare vero per certe frange di lavoratori. In generale , per la maggior parte dei lavoratori non vale il meccanismo neoclassico di decisione indipendente e autonoma se lavorare o meno a seconda della convenienza. E la convenienza era data dal calcolo tra il sacrificio del lavoro e la soddisfazione ricavata dal reddito, cosa che non funziona perché altrimenti — dice Keynes — si arriverebbe all’assurdo che in situazioni di crisi, con un reddito reale dei lavoratori che diminuisce, diminuendo i vantaggi, essi dovrebbero lavorare di meno spontaneamente. E questo non è un mondo reale. Secondo Keynes il mercato del lavoro funziona con altre regole. L’offerta di lavoro Sul mercato del lavoro ovviamente agiscono le due componenti che sono le famiglie, che mandano i propri membri sul mercato del lavoro a decidere se lavorare o meno e le imprese che domandano lavoro. Ora l’offerta di lavoro, cioè il numero degli individui che si presenta sul mercato del lavoro non dipende — come dicevano i neoclassici — dal salario reale, ma è legata al salario monetario. Keynes ricorda una cosa: quando si cerca lavoro, si contratta e si cerca di contrattare o singolarmente o anche attraverso il meccanismo della contrattazione collettiva, il salario monetario. Il salario reale non lo decidono i lavoratori perché il salario reale — cioè la quantità effettiva di merci che si possono acquistare — viene decisa sul mercato delle merci, sul mercato della moneta. Se i lavoratori hanno 100 € al mese, 200 € al mese, quello contrattano; poi, una volta che hanno ottenuto questo salario, si rivolgono al mercato delle merci e comprano le merci a prezzi che sono stati stabiliti dai capitalisti e non da loro[6]. Nella teoria keynesiana vi è dunque una separazione tra salario monetario e salario reale (connesso alla capacità di comprare le merci), dato che il potere d’acquisto reale non viene deciso sul mercato del lavoro ma viene deciso sul mercato delle merci. Questo contraddice un principio della legge neoclassica secondo cui esiste il calcolo di convenienza tra quello che si ottiene e quello che si dà come lavoro. Questo non avviene perché i lavoratori non possono fare nessun calcolo di convenienza non essendo loro a decidere i prezzi. È questa una prima conclusione di Keynes. Seconda conclusione di Keynes: non c’è nessun meccanismo automatico sul mercato del lavoro che porti alla piena occupazione. Una volta che si è determinato sul mercato delle merci quant’è il consumo e quanti sono gli investimenti eventuali dei capitalisti, ne deriva la grandezza del reddito prodotto nell’economia ed a quel reddito si avrà una certa occupazione che però non è detto assolutamente che corrisponda a quella di piena occupazione. Può essere assolutamente un caso che ci sia piena occupazione dato che normalmente si ha disoccupazione. È talmente improbabile che ci sia una situazione di piena occupazione che si può considerare normale il caso di disoccupazione. Questo è un punto che Keynes introduce in contrasto con la teoria neoclassica. Per Keynes infatti può anche avvenire che la disoccupazione porti ad un abbassamento dei salari, ma potrebbe anche verificarsi il contrario ed inoltre non è assolutamente detto che un abbassamento dei salari aumenti la domanda di lavoratori da parte delle imprese: gli imprenditori infatti non assumono in base al costo del lavoro ma assumono in base alla prospettiva di vendere le merci. Quindi non c’è ancora una volta nessuna garanzia di riassorbimento automatico della disoccupazione, il sistema può essere tranquillamente in equilibrio ma con disoccupazione, a meno che non intervenga lo Stato. Se interviene lo Stato con la spesa pubblica — allargando lo sbocco delle merci, aprendo prospettive favorevoli ai capitalisti — ecco che allora si investe e si assume. Un intervento di questo genere fa sì che si possa anche raggiungere la piena occupazione; ma senza l’intervento dello Stato la piena occupazione è un caso probabile, possibile, ma non necessario, anzi normalmente non si realizza. Quindi Keynes introduce il concetto di un’economia non diretta dallo Stato ma sostenuta dalla spesa pubblica in modo tale da essere economia di equilibrio, un’economia che possa anche raggiungere la piena occupazione. La produzione Si incontra subito una novità keynesiana: Keynes non si occupa del problema della produzione. Questo problema era assai importante per i classici ed è un aspetto essenziale in Marx poichè e nella sfera della produzione che si crea il plusvalore. Anche per i neoclassici la produzione era un aspetto molto importante, perché qui avvenivano le scelte tecniche, di comparazione costi-ricavi, eccetera. Keynes tralascia questi aspetti. Se si considera l’economia in un certo momento, la capacità produttiva si può considerare data e quindi essa può produrre una certa quantità la quale potrà essere aumentata con investimenti, oppure ridursi se si sotto utilizzano gli impianti. Però in un certo momento la capacità produttiva è quella che è, la produzione che si può ottenere dipende dalle decisioni dei capitalisti di utilizzarla appieno o meno, o di fare futuri investimenti. Su questo piano non c’è nessun confronto con Marx; mentre sull’aspetto crisi-disoccupazione Keynes arriva a conclusioni che si possono accostare a quelle marxiane — quindi il discorso della moneta e degli speculatori, il problema della domanda insufficiente, dei consumi e del comportamento dei capitalisti che possono decidere di investire o non investire — in questo caso invece il distacco è totale: infatti mentre per Marx la sfera della produzione è la sfera decisiva, per Keynes essa ha un ruolo irrilevante. La distribuzione Il problema della distribuzione era cruciale per i classici ed indicava come il prodotto sociale viene a dividersi in salari, profitti e in rendite. Esso era un problema cruciale anche per Marx: il concetto di giornata lavorativa, nel momento in cui si divide, tra lavoro pagato e lavoro non pagato, tra salario e plusvalore, tra salari e profitti, con tutto quello che questo significa in termini di conflitto di classe. La distribuzione, che è determinata essa stessa dalla produzione, era un punto essenziale nel mondo di Marx. Per i neoclassici la teoria della distribuzione era qualcosa di importante perché secondo la loro teoria vi è una legge secondo cui il prodotto sociale si distribuisce ai detentori dei singoli fattori di produzione in proporzione al loro contributo: è la legge della produttività marginale dei fattori. Keynes, invece, almeno esplicitamente, non dice niente sulla distribuzione. Sebbene però non ne tratti esplicitamente, i suoi scritti contengono osservazioni e spunti in merito alla distribuzione che saranno ripresi e sistematizzati dai post-keynesiani. La domanda L’elemento invece non trascurabile in Keynes, essenziale, determinante, è la domanda; il perno di tutte le economie è il problema della domanda effettiva: questo è il punto centrale, il punto forte dell’analisi keynesiana. Per i classici la domanda non costituiva un grave problema: per loro il problema era quello della distribuzione e della produzione. Non lo era perché nel mondo descritto da Ricardo i lavoratori ottengono un salario di sussistenza e devono consumare per vivere, i capitalisti investono automaticamente i profitti: quindi non c’è problema, poiché il lavoratore consuma necessariamente tutto, l’altro investe tutto: non c’è problema di crisi da domanda, di sbocco delle merci. Per i neoclassici non ci sono capitalisti e lavoratori, però le famiglie liberamente decidono se consumare o se risparmiare, ma poichè il risparmio andava automaticamente all’investimento, alla fine non c’era crisi di domanda nel sistema. Per Marx , al contrario, la domanda era importante: ecco allora che parte del discorso di Keynes si avvicina alla teoria di Marx. Come per Marx è importante il fatto che ci siano delle insufficienze di domanda dovute al comportamento dei capitalisti — in Marx, si ricorda, i lavoratori consumano quello che ottengono perché il loro salario è sufficiente per vivere, mentre sono i capitalisti che decidono se investire o meno, quindi, loro e solo loro possono creare le crisi — in Keynes non c’è questa visione di lavoratori che consumano e di capitalisti che possono decidere o meno di investire: ci sono invece famiglie e nelle famiglie ci sono capitalisti e lavoratori; le famiglie possono consumare o risparmiare — in questa visione il risparmio è un fatto negativo — e le imprese che possono investire o meno. Quindi, mentre nel mondo di Marx la crisi non deriva dai lavoratori che devono consumare per vivere, ma deriva dai capitalisti che possono decidere se investire o meno, nel mondo di Keynes la crisi deriva in parte dal comportamento dei lavoratori se risparmiano (e occorre avere redditi alti per risparmiare), ma soprattutto deriva dalle imprese (è questa la parte veramente vicina a Marx) quando decidono veramente se investire o non investire. La domanda è il punto cruciale per Keynes perché perchè è da essa che possono darsi le crisi: la domanda di merci può essere insufficiente in parte perché si risparmia troppo da parte delle famiglie, ma, soprattutto, perché le imprese decidono gli investimenti in maniera indipendente dal resto. Keynes parla di «spiriti animali» che animano gli imprenditori i quali decidono, secondo il loro istinto, magari le voglie o le paure politiche, le prospettive dell’avvenire, se investire o meno. Questo fa sì che ci possano essere crisi nel sistema, crisi però risolvibili con una aggiunta di spesa pubblica, con l’aggiunta di qualcosa che accanto ai consumi, accanto agli eventuali investimenti consenta di vendere il prodotto e addirittura di stimolare l’aumento della produzione. Il discorso keynesiano sulla spesa pubblica fa intendere tutta l’importanza conferita da Keynes alla domanda. Questa è una novità, infatti la sua teoria distrugge il mito dell’impresa che investe sempre (come nei neoclassici). Far capire come il risparmio sia un fatto negativo a livello macroeconomico, sconvolgeva soprattutto il pensiero dei contemporanei che rifiutavano l’intervento dello Stato nell’economia. La crisi del ‘29, la crisi degli anni trenta, quello che è accaduto in tutto il mondo nel dopoguerra, ha portato a far sì che lo Stato, grazie anche alle idee keynesiane, intervenisse nell’economia. Anche se non sempre è intervenuto per raggiungere l’obiettivo della piena occupazione. Certamente l’intervento dello Stato nei sistemi capitalistici è avvenuto sullo spunto delle teorie keynesiane, ed ha contribuito a sostenere i livelli della domanda, del reddito e della occupazione. NOTE [1] Appunti del corso “elementi di economia politica” tenuto nell’autunno del 1981 presso la FLM Milano dal Prof. Francesco Campanella, non rivisti dall’autore [2] Si osserva che in questa dizione economista il termine “speculatori” non ha niente di cattivo, di maligno: speculatore è colui che specula, che fa delle previsioni sul futuro, gioca in Borsa e cerca di avere dei guadagni; colui che deve saper scambiare moneta con titoli, o viceversa, in modo da guadagnare sulle oscillazioni del prezzi dei titoli. [3] Secondo i neoclassici invece, la decisione delle famiglie se consumare o se risparmiare dipendeva dal tasso di interesse, cioè dipendeva dal guadagno che la famiglia otteneva dal risparmio: per cui se sul mercato della moneta il tasso di interesse era alto esse risparmiavano di più perché ottenevano più guadagni, se era basso risparmiavano di meno. In conseguenza consumavano più o meno. Keynes invece sostiene che una famiglia non decide quanto consumare o quanto risparmiare in base al tasso di interesse. Per fare un esempio: oggi come oggi il tasso di interesse può essere altissimo ma se si ha un reddito di 700 € al mese, non si risparmia un euro! Se il tasso di interesse può essere alto, allora si dovrebbero comprimere i consumi per portare i risparmi in banca e riscuotere quindi gli interessi, ma se il reddito è basso non è possibile! Ne consegue che non è il tasso di interesse che conta ma il reddito. Questa affermazione che oggi sembra banale è dovuta a Keynes. [4] Nello schema neoclassico si concepiva che fossero invece gli stessi individui a scegliere liberamente se essere lavoratori dipendenti o lavoratori indipendenti, se essere imprenditori o se essere lavoratori, scegliendo liberamente secondo i vantaggi che potevano ricavare, se lavorare in proprio o se lavorare alle dipendenze altrui. Keynes sostiene che nessuno è così libero da potersi comportare in questo modo: esistono infatti due funzioni diverse, quella dei lavoratori da un lato e quella dell’impresa dall’altro, che agiscono in base a condizioni diverse. Quindi è inutile fingere che tutti noi siamo liberi di agire o da imprenditori o da lavoratori, ci sono le imprese e ci sono i lavoratori. E le imprese reagiscono in base a criteri diversi dalle famiglie o dai lavoratori. L’impresa ha come compito quello di decidere se investire e quanto investire e assume questa decisione in base a due elementi: il tasso di interesse (quello che si determina sul mercato della moneta) e le aspettative. [5] Si possono allora comprendere certe politiche fatte in molli stati, consistenti nello stimolare tassi di interessi bassi per incentivare le imprese a investire. Si pensi al caso italiano: si è detto che abbassando il tasso di interesse, dando finanziamenti agevolati, invece che al 20% soltanto al 5, al 6, al 2% per andare in Sardegna, in Puglia, in Campania, le aziende sarebbero andate ad investire nel Meridione. Ma le cose non sono andate così perché il meccanismo non è automatico. Se fosse così automatico l’Italia sarebbe un paese equilibrato, sviluppato e armonioso. [6] Keynes scriveva nel ’36, quindi non aveva in mente meccanismi di scala mobile o indicizzazioni di questo genere. Si porranno il problema i post-keynesiani: ma è proprio vero che i lavoratori si limitano a contrattare solo il salario monetario e non possono far niente sul salario reale? |